di Giuseppe Cappitta
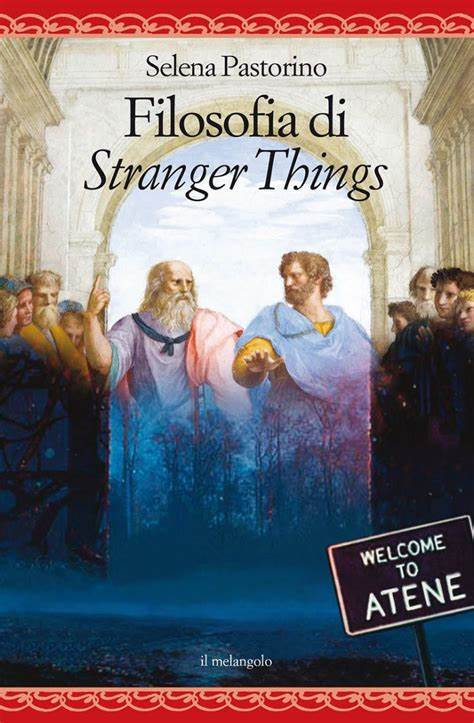
«La forza della storia messa in scena dai fratelli Duffer ha qui il suo nucleo pulsante: per affrontare le verità che agiscono dentro le bugie del mondo occorre saper guardare al reale oscuro che già da sempre siamo, sapendo che potremo continuare a crescere fedeli a noi stessi solo se continueremo a imparare come farci i conti e troveremo il modo di condividere l’onesta realtà di questo percorso con chi vorrà fare altrettanto».
Termina così l’introduzione di Selena Pastorino al suo saggio Filosofia di Stranger Things, in libreria da febbraio di quest’anno per Il Melangolo, frutto di un confronto filosofico con le prime quattro stagioni della serie tv scritta da Matt e Ross Duffer (in attesa della quinta e ultima, in programma per il 2024/25). Confronto vivo e illuminante, dal quale trarre innumerevoli spunti di indagine e riflessione.
La scelta di dialogare con Selena Pastorino – filosofa, docente, femminista, ballerina, madre –, e del titolo intorno al quale muovere le nostre considerazioni, diventa quindi esemplare nel porre in evidenza sia una forma di approccio interdisciplinare che è nostra intenzione valorizzare e promuovere, sia la trattazione di tematiche importanti poiché delicate, attuali e perciò urgenti. Ed è in questi termini che, indirizzando l’assunto iniziale, ci preme condividere questo percorso con chi vorrà fare altrettanto.
Fin dalle prime battute il tuo saggio appare particolarmente ispirato, sempre ben ancorato al soggetto principale e al contempo agile e lucido nel trasporre le tematiche fondamentali di Stranger Things (siano esse esplicite o implicite all’interno della narrazione filmica) nella nostra realtà, indagandola sotto l’aspetto antropologico, sociologico e certamente filosofico.
Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?
L’incontro con Stranger Things è stato piuttosto fortuito: stavo cercando insieme qualcosa su cui lavorare e una nuova serie da vedere. Ho deciso di partire da una delle produzioni in quel momento più gettonate e sono rimasta conquistata, anche per le assonanze con molti dei temi di cui mi occupo. È stato però l’entusiasmo del mio editore, nella persona di Simone Regazzoni, a motivarmi nel perseguire questo progetto di scrittura e non potrei esserne più felice.
Il target di Stranger Things è tra i più trasversali dell’intero panorama delle serie tv. Dapprima apparsa come serie teen/young adult, si è subito rivelato essere un prodotto cinematografico di grande spessore capace di conquistare spettatori di ogni età, dai più giovani (gli adolescenti coetanei dei protagonisti) e forse in misura ancor maggiore agli adulti (i giovani di ieri, nati o cresciuti ai tempi dell’ambientazione della serie). Com’è stata la tua adolescenza? Cosa guardavi, cosa leggevi? E quali letture in particolare ti hanno condotto alla ricercatrice e alla scrittrice che sei oggi?
Non so se basti definirla turbolenta. Ho vissuto gli anni dell’adolescenza con un’inquietudine e un’irrequietezza di fondo che posso dire non mi hanno mai abbandonata del tutto, funzionando però anche come motore del desiderio di imparare e fare. Mi sono sempre mossa nell’ambito della cultura “alternativa”, per cui molto di ciò che vedevo e, soprattutto, ascoltavo passava dal vaglio di una comunità dai confini molto frastagliati. In un certo senso ho sempre cercato dei classici a cui attingere, come a una fonte che non si limitasse alla sola visione, al solo ascolto, alla sola lettura. Alla filosofia mi sono avvicinata sin dal liceo con un timore amoroso a cui è stata corrisposta l’accoglienza di qualcosa come una casa. Abitarla è stata una scelta che ho compiuto poco più avanti, solo dopo aver cominciato a leggere Nietzsche.
Abitare la filosofia… Per inciso, questo dell’avvicinamento, del timore amoroso e dell’accoglienza corrisposta, è un ricordo nel quale ammetto di ritrovarmi (Nietzsche compreso). Lo stesso dicasi per la tua descrizione di ‘casa’ [capitolo 16], dalla ‘stanza-casa’ (e persino gli ‘oggetti-casa’) alle molte case-non-case della nostra vita.
Che ricordi hai del tuo spazio intimo da bambina? E quando hai sentito il bisogno di abbandonare le mura domestiche, in che modo le ‘case’ nelle quali hai vissuto hanno contribuito alla tua costruzione identitaria?
Curiosamente, sono una persona che ha sempre faticato a definire propria una casa, non solo per la circostanza perdurante che non ne ho mai posseduto una. Ho creato spazi che sentivo miei sin da quando ero bambina, nella casa dei miei genitori, ma il senso di appartenenza era sempre legato a situazioni ed esperienze che solo in parte erano legate all’ambiente architettonico circostante. Altrove, ho cercato di trovare delle dimensioni di intimità analoghe, un’aria di accoglienza per qualunque persona io fossi o stessi diventando in quel momento. La misura in cui ciò mi è e non mi è, di volta in volta, riuscito la porto dentro come la carne del mio corpo.
Nel libro fai riferimento a certe relazioni tra i protagonisti della serie capaci di proteggere spazi intimi, in cui trovare rifugio e forza per continuare a esplorare. Quanto c’è di tuo in questo concetto di ‘relazione-casa’?
Mi riconosco molto nel sentire la casa come una relazione sicura da cui muovere verso sé, l’altro e il mondo. Se sarò capace di essere qualcosa di tutto questo per mia figlia, potrò dirmi almeno un po’ felice del mio essere madre.
Olga Tokarczuk parla di una «casa infinita, senza indirizzo». Qual è la tua casa infinita?
Qualcosa che sta fra il mare e l’amore, che ha la potenza e l’inesorabilità, ma anche l’apertura e la grazia di entrambi.
Parliamo di linguaggio. L’immagine della dimensione linguistica che ci struttura e innerva «come un reticolo di vasi sanguigni che irrorano la carne di cui siamo fatti» è indicativa del modo con cui ne interpreti non soltanto le implicazioni, ma anche e soprattutto le conseguenze. Per tali ragioni, Filosofia di Stranger Things è anche un saggio sui vari aspetti del linguaggio e le sue molteplici forme, soprattutto in termini di identità e relazionalità. E giacché la lingua è tanto un veicolo quanto un limite, non manchi di citare due problematiche che ne palesano gli estremi, ossia la comunicazione mancata (vuoti di linguaggio) e il linguaggio in quanto strumento per l’esercizio di potere. Ma l’aspetto più attuale è forse quello inerente il linguaggio inclusivo. Nell’avvertenza scrivi di aver cercato di utilizzare un linguaggio quanto più inclusivo possibile, senza però eliminare del tutto il maschile sovraesteso, né optare per una scelta grafica che includesse le persone non binarie (a cui però ricorri nei social). Cosa ti ha scoraggiato dall’utilizzo di determinate scelte grafiche quali ad esempio lo schwa o l’asterisco? Ritieni che il loro utilizzo al di fuori del contesto dei social sia ancora prematuro o che possa risultare poco efficace o finanche controproducente?
Credo molto nella capacità del linguaggio di nutrire le relazioni, costruendo un terreno di incontri e scambi, di riconoscimenti e condivisioni, di crescita e consapevolezza. In questo senso, penso che sia giusto prima ancora che opportuno sperimentare soluzioni linguistiche che permettano a ogni persona di sentirsi chiamata e di poter parlare in propria voce. Non ho adottato alcuna soluzione grafica particolare perché il contesto editoriale ha delle norme che devono essere seguite. Non mi sento di dire che sarebbe stata una scelta prematura o controproducente, perché la lingua si cambia facendola e scrivendola, solo non mi sono sentita di prendere una posizione rigida optando per un segno invece di un altro. Nei social rispondo solo di me stessa e mi piace per molti motivi usare lo schwa, ma lì posso avere un riscontro immediato da parte di chi mi legge e quindi anche correggere quello che faccio in direzione di una maggiore inclusività.
Scrivi che la realizzazione di Stranger Things «è una forma di infinita sperimentazione di linguaggi». Tra questi citi forme di comunicazione non convenzionali in grado di estendere i confini del linguaggio e colmarne i vuoti. Il gioco di ruolo, ad esempio, determinante sia nel decifrare le situazioni di volta in volta affrontate, sia in termini relazionali all’interno delle dinamiche tra i protagonisti. Ecco quindi il gioco in qualità di «palestra sul piano identitario e relazionale».
Hai mai vissuto esperienze simili per curiosità, passione, evasione dalla realtà?
Forse le uniche mie esperienze vagamente paragonabili possono essere quelle dell’interpretazione di ruoli e personaggi nella danza. In questo senso sì, personificare altro rispetto a ciò che in quel momento si è aiuta a esplorarsi, sperimentarsi e scoprirsi, quindi anche a stare nel mondo umano con una diversa consapevolezza e apertura.
Proprio la danza è al centro del video musicale di Running Up That Hill di Kate Bush (1985), brano il cui utilizzo nella serie raggiunge il suo culmine nell’episodio Chapter Four: Dear Billy (quarta stagione). Nel saggio Filosofia della danza (Il melangolo, 2020) scrivi: «Dall’impegno del corpo nella danza c’è un qualcosa da apprendere e conservare anche qualora non si sia mai mosso un passo danzato». Viene in mente la scena di Mike e Undici in occasione del ballo d’inverno sulle note di Every Breath You Take dei Police (seconda stagione, Chapter Nine: The Gate): [Mike:] “Vuoi ballare?” / [Undici:] “Non so come si fa”. / [Mike:] “Neanche io. Vuoi scoprirlo?”
Cosa rappresenta per te la danza in termini comunicativi?
La danza mi ha sempre anzitutto permesso di trovare un modo per comunicare con me stessa. Non siamo riducibili alla dimensione logica, della ragione e del linguaggio, della coscienza e della trasparenza, per cui può essere prezioso imparare a entrare in relazione con altre dimensioni di sé, soprattutto quella corporea. Quando si rende possibile questo scambio, quando si riesce a rinnovarlo, si può poi parlare in molti più modi rispetto a quelli cui la comunicazione meramente linguistica ci costringe. Parlare danzando un poco nella vita, non solo in sala o sul palco, sapendo cioè impegnarsi in ogni gesto, senza resto.

Il concetto di identità è uno dei temi ricorrenti della tua analisi. A parer tuo il momento in cui siamo in condizione di scegliere come agire è ciò che permette di rispondere alla domanda “Chi sono?”. La costruzione dell’identità avviene quindi per mezzo dell’azione e della responsabilità relativa a quell’agire, cui associ l’importanza della memoria e delle relazioni, in particolare nel capitolo 21 dedicato a Mike, la cui storia affermi essere «la tessitura della sua identità nella relazione con l’altro». Sotto questo aspetto, è affascinante l’approccio utilizzato nel delinearne le caratteristiche in termini di crescita e relazionalità, dedicando a ciascun personaggio uno o più capitoli, a cominciare da Will. Ed è bello e interessante il fatto che il momento in cui parli dell’amore sia in relazione ai sentimenti di Will nei confronti di Mike, con il riferimento al «gesto d’amore più profondo e doloroso che possa darsi in una relazione: quello di lasciar essere l’altro nel modo che desidera». Accettarsi e accettare l’altro, nonostante le nostre e le altrui contraddizioni. Questione di compromessi, talvolta di sacrificio.
Perciò ti chiedo un parere su un pensiero di Claudio Magris a cui personalmente ho sempre dato un certo peso: «Ogni identità è anche orribile, perché per esistere deve tracciare un confine e respingere chi sta dall’altra parte» (Microcosmi, Garzanti 1997).
L’identità è un concetto complesso, perché è un processo complesso, vale a dire un insieme di pratiche che sempre e in ogni momento ci agiscono più di quanto riusciamo ad agirle, a padroneggiarle. Non si tratta quindi di qualcosa di univoco, eppure l’identificazione spesso sembra consistere proprio nel cercare una stabilità a un sé altrimenti sparpagliato, altrimenti troppo in mutamento. Altrimenti irriconoscibile ad altre persone. Quando cioè ci sforziamo di presentarci ad altri lo facciamo aprendo uno spazio di confronto che permette, veicolando esperienze intime di sé per tramite del linguaggio o di altre forme comunicative, di abitare una dimensione condivisa, in cui l’altro sia visibile e visto, e di lavorare a fare una dimensione collettiva, in cui identificarsi significhi tenere insieme quante più identità possibili, per tutte vederle e tutte riconoscerle. Tutte lasciarle essere, supportandole nel loro divenire. Insomma, il rischio che Magris adombra è reale, ma è possibile far leva sul suo “anche” per mantenere consapevolezza dei pericoli e fare dell’identità qualcosa di altro che un io autoreferenziale. Qualcosa di altro, qualcosa dell’altro, appunto. Magari anche sempre qualcosa per l’altro.

Qualcosa dell’altro, qualcosa per l’altro – come la musica, presente in Stranger Things non soltanto in qualità di strumento di espressione, «bensì come una vera e propria dimensione cui accedere per scoprirsi, parlarsi e riconoscersi». Non a caso il capitolo dedicato alla musica è introdotto dal ricordo delle compilation ‘casalinghe’, registrate o masterizzate, ricevute in dono o regalate per spirito di condivisione, per comunicare, per confidarsi, per conoscersi (aggiungo: legate com’erano al supporto musicale in quanto oggetto, la musicassetta o il cd, indispensabile per tradurre il sentimento in qualcosa da poter conservare, cui associare un rituale d’ascolto intimo e relazionale al contempo).
C’è però un pensiero che ti chiedo di approfondire: «La musica diventa spazio di ri-creazione del sé, capace di salvare dalla dispersione della disperazione e della colpa il senso di ciò che si è e che si ha quindi diritto di diventare». Hai mai vissuto situazioni in cui la musica – ascoltata, suonata, condivisa, interiorizzata – si è rivelata in tutta la sua potenza salvifica?
Ogni giorno e forse più volte al giorno mi accade quello che mi chiedi. Poter dedicare spazio all’ascolto apre già a una dimensione del possibile che è oltre il reale in cui sono sempre immersa e aiuta così a risignificarlo, ad accoglierlo e trasformarlo nell’azione. Che anche grazie alla musica può essere condivisa, perché è un’esperienza che può servire per centrarsi meglio riguardo a sé, ma anche qualcosa che fa legame. Vale per ogni modalità di fruizione, con diverse intensità e differenti capacità di agire su ciò che in quel momento è bisogno o desiderio: non sono capace a suonare, ma sentire la musica in cuffia o ad alto volume, cantare sommessamente o a squarciagola, ballare per cenni o come se il corpo non avesse confini, è una modalità di incontro di me e delle altre persone rispetto alla quale fatico a trovare un pari.

Torniamo al brano di Kate Bush. Il contenuto della canzone riguarda la relazione tra un uomo e una donna, innamorati a tal punto da far sì che il timore di perdersi, di perdere l’altro, anziché rafforzarli li rende insicuri e fragili. «Se l’uomo potesse essere la donna e la donna l’uomo», disse a più riprese Kate Bush, «se potessero fare un patto con Dio e scambiarsi i ruoli, capirebbero cosa significa essere al posto dell’altro». E ancora: «Un uomo e una donna non possono comprendersi a fondo, perché la loro natura glielo impedisce. Sono convinta che il cambio di prospettiva ci sorprenderebbe davvero».
Cosa ne pensi in termini di binarismo di genere e del suo superamento? E come interpreti il riferimento allo scambio dei ruoli nei rapporti interpersonali e dunque al cambio di prospettiva?
Credo che per comprendere qualcosa del binarismo di genere possa essere utile pensarlo come un costrutto storico e sociale insieme. In questo senso, è contemporaneamente qualcosa che non esiste e che pure esiste: non esiste come dato di fatto incontrovertibile, perfino naturale come dicono alcuni, ma agisce come struttura nelle nostre relazioni con le altre persone, soprattutto a livello educativo. Essere socializzati come maschi o femmine porta davvero a una differenziazione di prospettive, che però non è una specie di eredità biologica ma il frutto di un lavoro multisfaccettato che, in quanto tale, può e deve essere cambiato. Perché ne va della marginalizzazione delle persone e quindi delle condizioni concrete del loro vivere. Cambiare prospettiva è quindi necessario, sempre, in ogni dimensione del politico, vale a dire in ogni scambio relazionale, non perché si possano davvero comprendere gli altri, non possiamo davvero comprendere nemmeno noi stessi, ma perché è fondamentale sapere di non essere il centro verso cui tutto si dirige. I centri sono almeno tanti quante sono le persone.
Scrivi: «Qualsiasi generazione educata al binarismo di genere, all’idea che esistano solo due generi che dipendono dal sesso biologico e che esibiscono caratteristiche per lo più contrapposte, è del tutto inattrezzata a fare i conti con chi apparterrebbe all’altro gruppo umano». Utilizzi, non a caso, il termine ‘inattrezzata’: essere cresciuti in una società permeata dal concetto di binarismo di genere vuol dire non avere i mezzi – l’educazione, la mentalità, la cultura – utili a riqualificare il proprio atteggiamento. Per tale ragione, appare necessario agire nel modo più ampio possibile, dunque ti domando: la letteratura, il cinema, le arti si stanno muovendo coerentemente in questa direzione? E la scuola?
Come dicevo, credo che tutte le arti abbiano un ruolo non solo nel descrivere la realtà ma nel rendere possibile il suo cambiamento. Non so se esiste una coerenza che magari io stessa produco, selezionando alcune opere invece di altre, ma mi sembra che si cominci a respirare un clima culturale diverso cui tuttavia non corrisponde però alcuna garanzia di diritti e tutele. Partire da un cambiamento culturale che personalmente vedo già per lo più in atto nelle nuove generazioni può essere la strada per continuare a lottare affinché ci sia uguaglianza anche in terra e non solo nel cielo della teoria, se Marx mi perdona la parafrasi. La scuola in questo processo può avere un ruolo importante, ma deve riappropriarsi ogni giorno del proprio ruolo educativo, politico e culturale, facendosi comunità, viva e vivace, e non solo elenco di attività da performare individualmente e da valutare numericamente.
A proposito di educazione, mentalità e cultura – prendendo spunto dal rapporto genitori-figli in Stranger Things e muovendo quindi il discorso nell’ambito della pedagogia contemporanea nei confronti di una forma di genitorialità intensiva e ipervigilante – scrivi: «Acconsentire alla vulnerabilità dei propri figli, in quanto viventi, implica abdicare all’imperativo di proteggerli, pur senza poterlo fare, secondo una dinamica necessaria eppure irrealizzabile».
È possibile risolvere questa contraddizione teorica in termini pratici imparando a dominare la “condizione irreversibile” dell’essere genitori?
Come hai vissuto il tuo essere figlia e come intendi vivere l’essere genitore? E come vedi le nuove generazioni di genitori?
Esistono delle derive divulgative delle scienze psicopedagogiche che si allontanano molto dalle discipline originarie per diventare tutt’altro e, dal momento che non si può dare per presupposto che chiunque diventi genitore abbia il privilegio di aver compiuto anche un percorso di formazione teorica in merito, si tratta di un fenomeno da indagare con molta cura e consapevolezza. In questo senso, fatico a pronunciarmi sulle nuove generazioni di genitori, se non per la constatazione che non esiste un adeguato supporto sotto nessun profilo, almeno nel nostro paese, a chi voglia percorrere questa strada, con buona pace dei proclami a incrementare la natalità. Questo contesto rende estremamente difficile fare i conti con quella che è un’esperienza intensa di spostamento del baricentro, di presa d’atto delle proprie mancanze e quindi di ridefinizione di sé. È la vita più della vita, come ogni rapporto umano tra sé e altri che raggiunga una certa profondità sa essere, ma con tutte le peculiarità di questa relazione. Pensarla come relazione e non come ruolo è forse la chiave per poterla vivere e quindi praticare le ingiunzioni impossibili che questa dimensione comporta. È all’incirca così che intendo vivere la mia maternità, che sto provando a viverla da quando ho saputo di essere madre. Solo così, in qualche modo, come scrive Recalcati, ho provato anche a imparare come essere giusta verso la madre, la mia.
Ancora sulla vulnerabilità: il capitolo dedicato alla morte fa eco a quanto espresso sin dall’inizio, ovvero alla «insfuggibilità del nostro essere vulnerabili», quel destino che da sempre ci aspetta e che tuttavia rifuggiamo. Da un lato scrivi dell’irreversibilità della morte, del fatto che non la si possa dimenticare e che perciò l’unica alternativa possibile è «risignificare la propria vita di modo da continuare a viverla, tessendo di nuovo relazioni e scambi», dall’altro evidenzi come «il ricordo mantiene la dignità dei defunti, permettendo a chi resta di continuare, per parte propria, il dialogo con chi non può più rispondere».
Ricordi un momento in particolare in cui hai compreso ed elaborato appieno il significato della morte?
Ogni esperienza di lutto contribuisce a dare uno spessore diverso a ciò che attribuisco come significato o come senso alla morte, ma di fronte alla tua domanda ho pensato che solo nel momento in cui sono diventata madre ho cominciato a sentire diversamente in relazione a me stessa questa possibilità, questa certezza. In qualche modo a sentirne l’ineluttabilità, con tutto ciò che comporta.
Parliamo di ciò che chiami «paradosso dell’essere madre» e della duplice dimensione dell’essere madre e donna. Subito dopo aver trattato il rapporto tra Nancy e sua madre (nella fattispecie in quel dialogo dal quale fai poi scaturire una bella riflessione sulla sorellanza intergenerazionale), tratti il personaggio di Joyce, capace di racchiudere in sé tutti «gli aspetti mostruosi e meravigliosi del materno» e alla quale associ una innata potenza dell’istinto e dunque dell’agire. Scrivi: «Il materno appartiene a una dimensione difficile da dominarsi con la ragione». Questo perché, evidentemente, è una questione di cuore e corpo.
Ora, in Filosofia della maternità (Il melangolo, 2021) muovi le tue riflessioni dall’esperienza corporea della gravidanza; in Filosofia di Stranger Things affermi che la presenza del sangue nel corpo femminile «rimanda a una più complessa costellazione narrativa, in cui il diventare donna è di per sé fonte di paura e disgusto. Il tabù del ciclo mestruale è, in effetti, parte integrante di una specie di esorcismo sociale del corpo femminile».
Cosa intendi con “esorcismo sociale”? E come hai vissuto, se permetti la domanda, queste due fasi del diventare donna e madre?
Sarebbe difficile riassumere quello che è un percorso culturale, sociale e politico di millenni, ma in breve con “esorcismo sociale” intendo quella volontà della società di allontanare da sé una parte di sé nel momento in cui manifesta una propria autonomia (generativa in questo caso), ammettendone la riammissione solo in un’ottica di assoggettamento. Alla seconda domanda rispondo in questo modo, che chiarisce forse anche il senso della prima: non esiste esperienza corporea di chi è socializzata come donna che non sia essa stessa sociale, esposta, cioè, all’agire della società di fronte e su di esse, non tutelata nella sua intimità e nella prerogativa di deciderne quanto estendere quest’ultima ad altri. Viviamo in pericolo, piuttosto concreto a seconda dei privilegi di cui siamo dotate. Il mio, ma non solo mio, lavoro di decostruzione di questa oppressione è costante e mai concluso. E in quel “non solo mio” sta tutta la possibilità di realizzarlo.
Nel capitolo dedicato a Nancy tratti l’argomento dell’immagine stereotipica che la società ha del genere femminile, collocandola all’interno del panorama della lotta all’emancipazione femminile all’epoca dell’ambientazione della serie. Il tuo ragionamento, però, è molto più puntuale: è una critica alla ristrettezza di prospettive del cosiddetto femminismo della seconda ondata, il quale, una volta raggiunti determinati obbiettivi, si illuse di non dover proseguire oltre, ignorando il fatto di aver ottenuto una vittoria soltanto per una ristretta fetta della popolazione femminile.
È evidente la metamorfosi sociale delle donne nel tempo. Metamorfosi da un lato subita, dall’altro fortemente voluta. Trattasi però di una evoluzione – e lo si evince da ciò che scrivi – in continuo e incessante rapporto tra ciò che la donna era e ciò che la donna è. Pare ovvio che un simile confronto non può che alimentarsi di generazione in generazione, quindi: cosa ci si può aspettare dal lascito del femminismo giunto alla sua quarta ondata? E a tal proposito, sei favorevole al “costrutto dell’onda”?
È arduo rispondere in riferimento a fenomeni storici che portano, proprio nel loro essere tali, una duplice complessità: da un lato è difficile trovare dei segnavia efficaci per poterne leggere le tappe evolutive, dall’altro lato non si può che tentare di farlo. Per dirla in poche parole, non credo che il femminismo possa essere se non intersezionale e quindi aperto a sostenere la lotta di ogni persona marginalizzata. In tutti gli altri casi ci si può definire femministi solo abusando di questo termine. Mi sembra quindi importante non valorizzare solo le possibili eredità, ma anche l’urgenza di chi sta lottando ora e con uno sguardo al futuro più ampio di chi porta con sé invece un ampio passato. Soprattutto perché la tentazione socio-culturale è sempre quella di svilire le nuove generazioni facendo pendere sul loro capo una patente di legittimità che, nella lotta, non spetta proprio a nessuno attribuire. Proprio per la pluralizzazione che il femminismo deve incorporare, non penso si possa eludere la critica al costrutto dell’onda tanto facilmente. Il che non significa che non sia uno strumento da poter risignificare, ma che lo si deve poter fare tutte insieme e non solo chi finora lo ha già da sempre usato per scrivere la storia con il proprio nome.
Annie Ernaux afferma che «viviamo sotto l’egemonia dello sguardo maschile» e che «i libri danno spesso una visione maschile del mondo». Pur trattandosi di considerazioni innegabili, oggi siamo testimoni di importanti segni di affermazione del pensiero e della visione femminile, nella fattispecie in letteratura. Dagli esordi letterari alle conferme, passando per un sempre più ricorrente numero di riconoscimenti cui affiancare la riscoperta di autrici del passato fin troppo facilmente ignorate o dimenticate, sembra che la visione del mondo al femminile stia finalmente affermandosi a più livelli in tutta la sua lucidità, forza e sensibilità. Lo stesso dicasi per la visione e l’impegno relativi all’ambito LGTBQ+ e alla sfera sessuale nel suo complesso (viene in mente, tra le molte opere degne di nota, il recente e subito acclamato Dysphoria Mundi di Paul B. Preciado, edito in Italia da Fandango).
Ritieni che una simile evoluzione nel panorama letterario rispecchi più o meno fedelmente i mutamenti sociali e politici ai quali stiamo assistendo?
Una delle condizioni che caratterizzano il panorama letterario al giorno d’oggi è forse quella della moltitudine di voci. Se è vero che il riconoscimento di un Nobel spezza l’insindacabilità del giudizio di gusto, quanto meno perché impone di interrogarsi sul valore di opere talvolta sconosciute a molti, penso che nella pratica quotidiana non sia così semplice approcciarsi a letture che non ci corrispondono già in qualche modo. Che non sia semplice non significa però che sia impossibile, per cui anche ciò che la letteratura non rispecchia, perché ancora non c’è, contribuisce in maniera importante a crearlo, rendendolo pensabile e vivo, quindi anche realizzabile insieme oltre le pagine dei libri.
Trovo opportuno approfondire il personaggio di Robin, introdotto a partire dalla terza stagione e divenuto subito determinante. È a lei che attingi per trattare temi differenti quali le discriminazioni a cui era – è – soggetto il genere femminile, le difficoltà nel vivere con serenità la propria omosessualità, le problematiche relative ai soggetti neuroatipici (soprattutto in relazione al superamento di quella mentalità che li vuole aderenti a un certo tipo di narrazione fin troppo limitata). Dati simili presupposti, il personaggio di Robin sembrerebbe il candidato ideale a rappresentare uno dei temi più ricorrenti nel tuo saggio, quello dell’intersezionalità.
Nel mettere in risalto i pregi e insieme i limiti di Stranger Things trovi il modo di trattare argomenti quali il genere, l’etnia, la classe sociale, la disabilità, l’orientamento sessuale, l’età, dunque le problematiche di tipo relazionale e discriminatorio ad essi relativi. Cosa resta fuori in Stranger Things?
Credo che non si possa parlare di un approccio compiutamente intersezionale nella serie, sebbene ci siano tentativi di ampliare la complessità delle questioni, lasciando intravvedere come non si possano mai comprendere a pieno adottando un’ottica esclusiva. Manca in molti casi quel respiro politico che permetterebbe di inquadrare in un orizzonte ben più ampio ciò che resta per lo più sullo sfondo, come le condizioni economiche. Non è questo l’obiettivo di Stranger Things che svolge comunque un egregio lavoro nel risvegliare consapevolezze con una narrazione attenta e densa, in cui c’è sempre molto di umano, vale a dire di ciò da cui dovremmo sempre ripartire.
Nel capitolo dedicato a Dustin scrivi: «Chiarire che cosa sia da considerare “normale” è, sempre, un atto normante, a partire dal quale si impongono quelle regole che faranno della società una casa per alcuni e un inferno per gli altri. Decostruire questo atteggiamento e, nel contempo, elaborare anche alternative praticabili è un lavoro sociale, politico, culturale, che nessun atto isolato è in grado di esaurire e rispetto al quale, tuttavia, ogni gesto può, quindi anche deve, contribuire».
Dove e come si colloca il ruolo della filosofia in questo contesto da sempre fonte di discriminazione e oggi forse più che mai attuale?
Posso dire dove dovrebbe collocarsi, cioè in ascolto. Di esperienze umane e professionali, solo nutrendosi delle quali potrebbe usare gli strumenti disciplinari che le sono propri per apportare un contributo significativo. In caso contrario, il rischio della speculazione disincarnata, che nella fattispecie significa anzitutto cieca al dolore, prende il sopravvento. E può accadere a chiunque pratichi la filosofia dimenticando di riportarla al reale di cui vorrebbe pensare. È una questione di esercizio e quindi anche di umiltà, che però ha ricadute sul collettivo di cui non ci si può che assumere la responsabilità.
Se pare impossibile «rimuovere l’oscuro che intrama le nostre vite e il dolore che le costituisce» ma lo si può «arginare o risignificare con l’aiuto di altre persone», se esistono «demoni che si animano dentro di noi e restano in sospensione come le spore del Sottosopra, tanto più capaci di stordire e intossicare quanto più si provi a ignorarle» a tal punto che l’unica soluzione pare essere quella di «prendere una posizione e tradurre la propria decisione in azione» – in che modo possiamo trasporre la situazione di Will (e dunque di questo oscuro potere a cui è assoggettato e che diventa costrizione, espropriazione e possessione) nella nostra realtà e nell’ambito delle relazioni interpersonali? È possibile che ti riferisca, traducendo ed estendendo il fenomeno, a coloro che soffrono di depressione? O alle vittime di bullismo o violenza sessuale? Oppure, ancora, alle relazioni cosiddette tossiche?
No, andrei molto cauta nel rivolgermi a chiunque affronti situazioni quali quelle che nomini, sia nell’istituire un paragone con immagini che hanno un potere narrativo forte e che quindi rischiano di impedire la possibilità alle persone coinvolte di narrarsi in prima persona, sia nel suggerire come ci si dovrebbe poter comportare o quali rimanenze non si possono che accettare perché i vissuti citati, come tutti ma con una magnitudo maggiore, devono poter essere tutelati nella loro singolare irriducibilità, per cui non si può dire nulla in generale che valga per tutti e per ciascuno. Il mio riferimento è piuttosto quello più aspecifico dell’inconscio e del pulsionale, intesi come dimensioni che sfuggono la logica della logica, che ci muovono e chi chiamano a farci in relazione a esse, senza poterle davvero ignorare.
Il capitolo su Murray pone attenzione su alcuni concetti a te molto cari: l’importanza, anzi la necessità del pensiero critico, l’esercizio del dubbio, la lucidità di sguardo, essenziali nell’indagare la questione relativa all’articolazione pluriprospettica della verità, ovvero una verità composita e plurale. Pare centrale, nel tuo pensiero, la critica alla polarizzazione delle opinioni, alle posizioni che si ergono a detentrici di verità assolute, e a tal proposito scrivi: «Il vero non è disgiunto dal racconto che se ne fa». Parli, nella fattispecie, di ‘narrazioni’, e a quanto «ogni narrazione si intrecci a esigenze personali e sociali, collettive e identitarie, politiche e culturali, e che è proprio in questo che si trova una verità».
C’è una frase di Paul Ricœur – «Io sono ciò che mi racconto» (Sé come un altro, 1990; Jaca Book, Milano 1993) – che mi pare leghi i concetti di identità e verità, ma lo fa suggerendo i suoi contrari: falsità, menzogna, finzione. Perché ciò che ci raccontiamo non può che essere parziale (in entrambe le accezioni: incompleto e di parte) e spesso illusorio. Questo mi riporta all’etimologia della parola greca per ‘verità’: ἀλήθεια, alétheia, (α- più λέθος, léthos), ‘non nascondimento’, ‘disvelamento’, un processo di rivelazione che procede per rimozione. Ma la narrazione, il raccontare e il raccontare a sé stessi è invece un processo composito di aggiunta, di dettagli, impressioni, opinioni.
Noi tutti ci affanniamo a raccontare il mondo e noi stessi al mondo, ci affidiamo e confidiamo in narrazioni che siamo certi non porteranno ad alcuna verità. È in questa presenza/assenza della Verità, in questo scarto dell’intelletto – mi domando e ti domando, retoricamente – che l’umanità è destinata a perdurare anziché accontentarsi e finanche giovare delle uniche Verità che sappiamo essere certe e inesorabili (la nostra inutilità cosmica e la morte)? Per ciò che sappiamo e che soprattutto sappiamo di non poter mai sapere, siamo noi esseri umani le Strane Cose di questo mondo?
Con una boutade, siamo strani a noi stessi e non riusciamo a farcene letteralmente ragione. Proprio per questo qualsiasi narrazione che permetta di esplorarsi può essere preziosa per comprendersi, per comprenderci, anche nel senso di prenderci insieme in ciò che di comune e umano abbiamo. Ciò vale tanto per i racconti in senso stretto, qualche che sia il mezzo che li veicola, quanto per l’incessante, inevitabile narrare con cui ci facciamo ogni momento.

Scrivi che il Sottosopra «è l’elemento narrativo con maggiore densità filosofica di tutta la serie». Più di tutto, appare rilevante il riferimento al Sottosopra come «qualcosa che potremmo quasi chiamare verità», in quanto «dimensione costitutiva della nostra realtà, che si nasconde all’ombra eppure è essenziale». Sin dal prologo “Gli amici non mentono” poni in evidenza il concetto di verità (o di percezione della verità), anch’esso trattato in termini relazionali, affrontato per mezzo di differenti personaggi e situazioni, tematiche e riflessioni, e non a caso argomento ultimo dell’intero saggio. Sarei tentato di citare la frase finale relativa a «quell’onestà che dovrebbe essere propria della filosofia», ma preferisco che le nostre lettrici e i nostri lettori possano scoprirla e apprezzarla appieno dopo aver fatto esperienza del libro, del viaggio che ci hai riservato, perciò mi limiterò a chiederti: ritieni che vi sia qualcosa per cui la filosofia contemporanea manchi in termini di onestà?
Mi permetto di includermi nel novero dei filosofi contemporanei perché, qui come sopra, nessuno è immune dalle derive più pericolose della propria attività. Forse ciò su cui non ci è sempre facile raggiungere una piena onestà è l’urgenza delle questioni di cui ci occupiamo: forte la convinzione , che la filosofia non abbia il suo valore nell’utilità, rischiamo spesso di chiuderci in un’autoreferenzialità compiaciuta e funzionale quasi esclusivamente al nostro percorso individuale. Espungere la performatività dal filosofare contemporaneo è battaglia lunga, ma nel frattempo potrebbe aiutare mantenere uno sguardo consapevole alla dimensione umana cui apparteniamo, come parte e non come vertice.
In Filosofia di Stranger Things hai scritto da filosofa, da femminista, da appassionata di serie tv e cinema (in particolare di horror) e, come detto e forse soprattutto, da madre. Cosa e come ti vedi a scrivere in futuro?
Spero qualcosa che possa aiutare a pensare il futuro come possibile e quindi anche a praticarlo come attuabile.
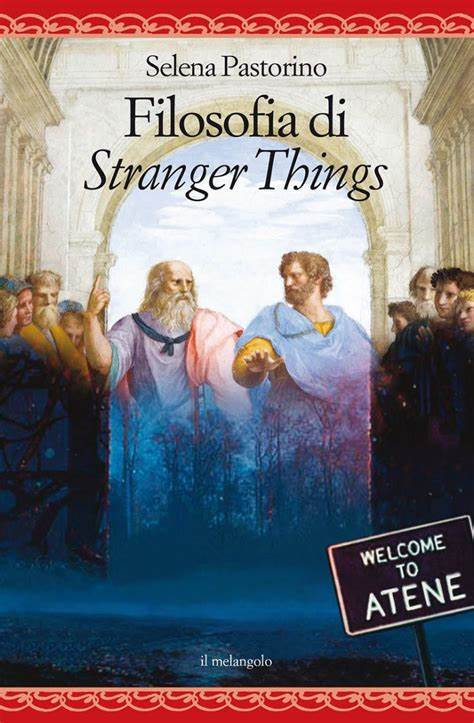

Selena Pastorino (Genova 1986) è Dottoressa di ricerca in filosofia e docente liceale di Filosofia e Storia. È membro del Seminario Permanente Nietzscheano e collabora con diverse testate online. Sul pensiero di Friedrich Nietzsche ha pubblicato Prospettive dell’interpretazione (ETS, 2017), Per la dottrina dello stile e Da quali stelle siamo caduti? (Il melangolo, 2018). Per i tipi del melangolo ha pubblicato: Filosofia della danza (2019); Filosofia della maternità (2021). Nell’ambito della pop-filosofia è autrice dei volumi Black Mirror. Narrazioni filosofiche, con Fausto Lammoglia (Mimesis, 2019), Il male quotidiano. Incursioni filosofiche nell’horror, con Davide Navarria (Rogas, 2022) e Filosofia di Stranger Things (Il melangolo, 2023).
Illustrazioni di Valeria Dimartino
Vuoi sostenere L’Appeso


Lascia un commento