L’agonia della morale e l’estetica della perdizione: breviario per tempi ipocriti
«Sai cos’è il bene, Galina?» chiede Hugo Boll, protagonista e narratore di Inaugura stanotte il secolo del bene (Wojtek Edizioni). «È di chi fare di buono, Mister Hugo», risponde la tanatoesteta slava alla quale è concesso di prendere una banconota. «E il male sarebbe lasciare l’altra banconota lì dov’è?» chiede infine l’uomo. Da questa scena iniziale — un cadavere imbellettato, un figlio che infila banconote nella bocca del ricco padre morto — prende piede il romanzo di Vincenzo Montisano, un testo feroce e magnetico, in cui bene e male respirano lo stesso vento: maschera cosmetica del potere, uno, materia che rifiuta di essere truccata, l’altro.
L’amicizia che mi lega a Vincenzo Montisano mi ha permesso di seguire negli anni, da una posizione privilegiata, la lunga e tormentata gestazione di questo romanzo, così come il percorso intellettuale dell’autore, nutrito da letture fondative e da una progressiva consapevolezza del proprio sguardo e del proprio talento. Partendo da quello che secondo me è il fulcro concettuale dell’opera, il principio generativo che ne orienta la costruzione narrativa e simbolica — la disamina delle categorie di bene e male intese però non come poli contrapposti, ma come principi osmotici, espressioni di una medesima energia tragica — è possibile addentrarsi in una riflessione sulle risorse dell’autodistruzione, sulla corruzione etica, sulla decadenza dei tempi… questa convalescenza incurabile.
Hugo Boll, erede di un padre «dalla postura sociale invidiabile», attraversa il lutto del genitore come un viaggio nell’abisso del secolo. «La villa vibrava quella notte di gioia imprevista», annota, «come se anche i morti si fossero accorti di essere vivi». È il battesimo di un narratore che scambia la vita con la necrosi, il sentimento con l’indifferenza (come spesso accade a chi, scontrandosi con “l’ideale”, ne esce spezzato). È difficile leggere questo romanzo senza pensare ad autori come Dostoevskij, non per la tentazione di “redimere il male”, ma per l’incredulità nella bontà stessa: come Raskol’nikov o Stavrogin, Hugo Boll si muove in un mondo in cui la colpa è un residuo estetico, non più un dato etico; tuttavia, laddove Dostoevskij cercava la salvezza nel dolore (spirituale, redentivo, paradossale), Montisano afferma la sterilità di ogni redenzione. Il suo è un universo post-cristiano, o meglio: post-umano, in cui il bene è ridotto a categoria di mercato, e il dolore rivela soltanto la putredine celata sotto la vernice del decoro, assecondando così la lezione filosofica di autori come Bataille o Cioran, ma con una violenza visiva che ricorda Ballard, Bernhard o Céline.
La scrittura, ipnotica e viscerale, alterna l’eleganza del gesto alla brutalità del pensiero («Se ce ne fossimo andati così, tutti quanti, d’un tratto espulsi dalla sfera materiale della vita, saremmo colati lungo un’uretra infinita come calcoli renali di un dio distratto»), con uno stile che sembra eseguire magistralmente autopsie linguistiche e che si muove in una zona di confine tra prosa e poesia intrisa di immagini sacrali, simboliche e febbrili («L’odore metallico della stanza operava come un anestetico spirituale: sedava la memoria, lasciando che il dolore si disperdesse nei capillari del linguaggio»). Il “secolo del bene” è allora il secolo dell’anestesia morale, della filantropia tossica, della compassione come spettacolo, mentre il male, paradossalmente, è l’unico residuo di vitalità rimasto, l’unico impulso dionisiaco che ancora conosce la sincerità della carne.
Se Nietzsche auspicava di oltrepassare il dualismo tra bene e male che ha tenuto in ostaggio la coscienza occidentale per millenni, Montisano ne mette in scena la reincarnazione narrativa. Potremmo dire che Hugo Boll è un oltre-uomo alla rovescia: non colui che afferma la vita, ma chi ne smaschera la simulazione («Ma che cos’è la speranza, se non un’altra fottuta idea?»); egli non è più disposto ad accogliere e salvaguardare, in nome di un ostinato vitalismo da “sogno”, il sentimento di illusorietà che pervade il mondo, e massacrando questo sentimento, così come sosteneva Nietzsche ne La visione dionisiaca del mondo, ecco che ne subisce gli effetti patologici: il sogno non ristora più, e cessa la sua forza naturale e risanatrice. La sua “volontà di potenza” si è degradata in volontà di possesso, il denaro diventa la nuova metafisica, e la compassione diventa la più subdola delle tirannie. «Il secolo incalza», scrive Montisano, e non c’è posto per la tragedia. Tutto diventa neutro, anestetizzato, persino la colpa. Così il romanzo fa esplodere la tensione tra il bene come strumento di controllo e il male come gesto liberatorio, impulso di vita che non si lascia addomesticare, ma che brucia anche nella disperazione; del resto c’è una tracotanza nella bontà, come si legge nell’opera forse più famosa del filosofo tedesco, che si presenta come malvagità. Laddove l’apollineo ordina e misura, Montisano lascia che l’ebbrezza del caos invada la scena. L’oscenità, il desiderio, la morte e il denaro sono le sue maschere dionisiache: immagini di una vitalità che si rigenera nella rovina. È il ritorno dell’istinto, della materia, del corpo come unico “Luogo” dove ancora si può dire la verità.
In ogni uomo niente è più reale e genuino della sua volgarità, scrive Cioran nel suo Sommario di decomposizione, e questa volgarità è fonte di tutto ciò che è elementarmente vivo. Ma d’altra parte, più si è inseriti nella vita, più si è spregevoli (come suggerisce Montisano immaginando l’epitaffio di un personaggio chiave, Karl Olsen, “neurochirurgo, il più idiota servitore delle logiche, la più integrata tra le scimmie di basso rango”). Colui che non sparge attorno a sé una vaga irradiazione funebre, e il cui passaggio non lascia una traccia di malinconia proveniente da mondi lontani, appartiene, dice Cioran, alla sub-zoologia, e più specificamente alla storia umana. E alla storia umana appartiene la città in cui è ambientato il romanzo — universalmente, la città di *** — scintillante di pioggia «offriva lo spettacolo cromatico delle sue elettrificazioni… una mantide iridata che fluttuava sopra la banalità della terra». Un organismo meccanico, post-umano, per l’appunto, che divora i suoi abitanti, un ventre elettrico dove ogni luce è una ferita che non si rimargina. Si vaga tra bar, locali a luci rosse, vicoli dove «la disperazione dei reietti e dei fottuti d’ogni etnia trovava sfogo». Qui il bene e il male hanno cessato di esistere: non ci sono più colpevoli, solo superstiti che si battezzano a vicenda «come dèi pagani», l’abiezione come ultima forma di comunione possibile. Eppure, sotto quella superficie di luci e degrado, qualcosa di più profondo si sta diffondendo: una malattia. Non solo la corruzione morale, ma un’epidemia reale, quindi, una pestilenza di amputazioni che segna i corpi e le coscienze. La città è piena di figure monche, ricomposte, di uomini e donne che avanzano su protesi come su dogmi. «C’è chi perde un arto, chi la memoria, chi la fede». La malattia è una forma di adattamento, è metafora organica del secolo del bene: un mondo che si taglia via le parti dolorose per sopravvivere, che preferisce la protesi alla carne, l’integrità apparente alla sofferenza reale. In questo paesaggio di monconi e innesti, il corpo, come abbiamo detto, diventa l’ultimo luogo di verità, il teatro della colpa e della resistenza, ma il corpo è anche prigione materiale dell’essere, non è solo limite fisico, ma frontiera metafisica tra interno ed esterno che impedisce la fusione con il mondo («Tagliandosi, ustionandosi, percuotendosi, levandosi di mezzo, gli esseri tentavano l’evasione da quella clausura. Si dissipavano, ricercavano la fonte di una promiscuità completa con il fuori»). L’uomo è condannato alla propria individualità, e la materia è ciò che ci separa più radicalmente dagli altri e dal tutto. L’automutilazione e il suicidio vengono interpretati come tentativi di evasione dal carcere corporeo («Nati in una prigione, con fardelli sulle spalle e sui pensieri, non arriveremmo al termine di un solo giorno se la possibilità di farla finita non ci incitasse a ricominciare il giorno dopo» dice ancora Cioran nel suo Sommario), un modo estremo per cercare una promiscuità assoluta con il fuori, con l’infinito, con il nulla. Colui che non abbia mai concepito il proprio annullamento, che non abbia mai pensato alla molteplicità di mezzi con cui sopprimersi (dalla corda alla pallottola, dal veleno al mare), in quest’ottica, è un essere spregevole, come un verme che striscia su una carogna cosmica.
Il bene, quindi, è l’ultimo inganno che ci resta; il male è sincero, ma le due categorie collimano. Hugo guarda il mondo come un residuo estetico, un relitto illuminato da neon lividi, violacei, infermi. Non cerca redenzione, ma lucidità: «Mi suggeriva una meta desolante e però più onesta: la perdizione». È questo il punto estremo del libro, dove la morale implode nel suo contrario. Inaugurare il secolo del bene, quindi, significa attraversare la notte del male fino a riconoscerne il volto. «Il sapore del tabacco mi parve più gradevole all’esterno della villa», scrive Hugo uscendo dalla veglia paterna. È la prima vera confessione di piacere del libro — e coincide con l’uscita dal culto della virtù.
Se alla fine del romanzo il lettore fosse portato a pensare che in un mondo malato non ci sia nulla di più inutile della gentilezza, non mi sorprenderebbe; Montisano aggiungerebbe — se lo conosco almeno un poco — che non c’è nulla di più pericoloso del bene quando questo diventa sistema («Qui persino il successo equivale al fallimento, perché avere successo significa soltanto che sei la carne di cui si nutre il sistema» scrive Mark Fisher in Realismo capitalista, testo fondamentale per il nostro, citato in esergo a questo libro). Inaugura stanotte il secolo del bene è la cronaca di questa malattia, il suo inno e la sua catarsi, è una denuncia e un requiem, un inno funebre al nostro tempo anestetico, è un libro che non cerca lettori consolati, ma complici — disposti a guardare nel volto del cadavere e riconoscere, per un istante, la propria immagine riflessa.
In copertina: ph. © Debora De Bartolo
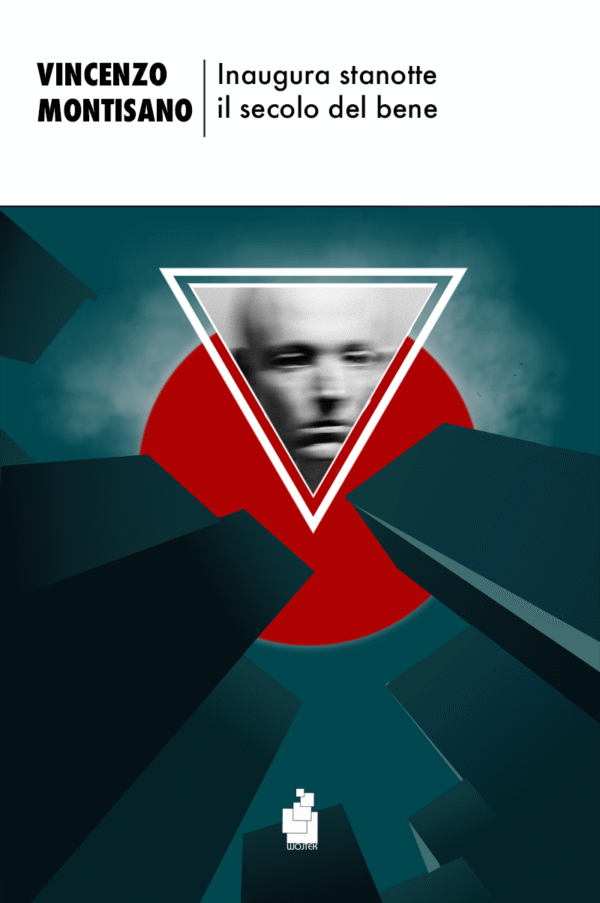
Vincenzo Montisano, calabrese classe 1988, con il romanzo Inaugura stanotte il secolo del bene è stato finalista al Premio Neri Pozza e ha pubblicato nel 2024 Logica degli incendi (industria & letteratura). Fa parte dei collettivi di scrittori Nucleo Kubla Khan e La Masnada. Ha scritto su varie riviste online tra cui: «L’Equivoco», «Pangea», «Atomi – Oblique», «Rivista Blam!», «micorrize». Per «L’Appeso» è stato ospite della rubrica Ingressi a cura di Emiliano Peguiron e ha scritto il racconto Lutto fase tre apparso nel Supplemento tematico VI (Mutamenti).
Andrea Napoli è tra i fondatori dell’associazione letteraria Nucleo Kubla Khan di Cosenza. Diplomato in pianoforte e laureato in filologia moderna, è oggi un insegnante di lettere nelle scuole secondarie. Al suo attivo le pubblicazioni Il pendolo (2009), Infera suite (2013) e Gengive (2021).
Vuoi sostenere L’Appeso?


Lascia un commento