{dis}impegno letterario #3
a cura di Simone Sciamè
Sulle fascette, sulle quarte di copertina, nelle recensioni, nei comunicati stampa, nei premi letterari, negli articoli delle riviste di cultura: “realtà” è una parola onnipresente. Wikipedia dice che “La realtà è, in senso lato, ciò che esiste effettivamente o che può esistere, di solito in contrasto a ciò che è apparente, illusorio, immaginario o fittizio. A volte viene anche contrapposta al sogno. In senso proprio, si intende il modo di essere delle cose in quanto esistono fuori dalla mente umana o indipendentemente da essa. Questo concetto pone diverse questioni sia nella scienza sia nella filosofia, entrando in contatto con la domanda ontologica dell’essere”. Ma cosa significa, oggi, parlare di realtà in letteratura e in editoria? L’ho chiesto a Maddalena Crepet e Andrea Pomella, che ringrazio per aver accettato l’invito.
Maddalena, tu hai scritto un romanzo in cui si raccontano la tensione degli anni ‘70, la lotta armata, la società che cambia e la gioventù perduta che, se guardiamo bene, ha tratti in comune con quelli di ogni generazione, quindi forse la generazione che racconti può essere, anche se declinata in maniera diversa, la nostra generazione. Andrea, nei tuoi libri hai indagato la depressione, il rapporto padre-figlio, ma anche le ultime ore di Aldo Moro. Perché abbiamo la necessità di raccontare il reale?
Andrea:
Innanzitutto ci dobbiamo mettere d’accordo su che cosa è il reale. Noi tutti viviamo un’epoca letteraria, culturale, che fa di questo benedetto reale un po’ il fulcro e il centro di ogni tipo di rappresentazione, ma è una roba che va avanti da almeno una ventina d’anni, anche forse di più, diciamo anche venticinque anni. È un realismo che di volta in volta torna, ciclicamente nel corso della storia, a impossessarsi delle idee degli scrittori, dei registi, di chi fa cultura. Sulla necessità di raccontare la realtà mi viene in mente un saggio uscito nel 2010, mi sembra, di David Shields, Fame di realtà, che analizzava proprio questa cosa qui e sosteneva che in un’epoca come la nostra non era più possibile inventare, ma l’unica possibilità di dare una rappresentazione degna della contemporaneità e del mondo era usare i mezzi del collage. Lui riuniva un po’ di pezzi, tant’è che nella stessa fame di realtà non c’è nulla di originale, lui lo dichiara proprio, sono tutti pezzi estratti da altri libri, da altre cose. Questa fame di realtà è avvertibile a tutti i livelli, dalle trasmissioni televisive, dal primo Grande Fratello a oggi. Anche quando si fa fiction, al cinema si cerca di dare una dimostrazione, si usa una fotografia che può sembrare quasi da documentario. Non è possibile oggi viaggiare con la fantasia, quasi, per dare una rappresentazione degna di questa contemporaneità. Questo perché probabilmente la contemporaneità è qualcosa di enormemente sfuggente, complesso, difficile da manipolare. Quindi c’è un ritorno forte al romanzo storico, alla memorialistica, al reportage, a tutte queste cose che danno, a mio giudizio, l’impressione di cogliere il reale, il dato reale, ma è un’impressione. Perché io non sono affatto convinto che la realtà possa essere portata dentro a un’opera, dico opera in generale, non solo opera letteraria, perché anche quando noi ci poniamo l’obiettivo di essere il più oggettivi possibili e quindi rispettare al massimo i fatti “realmente accaduti” interviene sempre la finzione, quindi alla fine noi viviamo la forte illusione in cui pensiamo di saccheggiare la realtà, il reale appunto, ma usando quelli che erano i mezzi storici e letterari, per esempio, dell’Ottocento, della fiction e di tutte le belle cose che sappiamo.
Inquadri questa incapacità di dedicarsi alla propria fantasia come un difetto?
Andrea:
No, assolutamente, la inquadro come una richiesta del mercato. Il mercato pretende un’illusione di realtà, il famoso “tratto da una storia vera”, perché viene scritto sulla fascetta editoriale? Perché si ritiene che attiri il lettore. Ci sono delle opere meravigliose che hanno un appoggio di pura fiction, ma faticano a imporsi nell’immaginario contemporaneo. Guardiamo gli ultimi premi Nobel, guardiamo le vittorie del premio Strega. La cosiddetta “no fiction novel”, termine su cui si potrebbe stare a discutere a lungo, sembra avere una marcia in più nella rappresentazione del reale. Non è che io dia giudizi di qualità, ci mancherebbe, anche perché c’è una feroce diatriba su queste questioni, feroce e inutile da commentare e da tenere in piedi, perché è una guerra per bande che non ha nessun tipo di cittadinanza.
Maddalena:
Sì, queste riflessioni mi hanno aperto un sacco di finestre mentali anche abbastanza polemiche. C’è un andazzo, io penso, nel cinema nei confronti dei biopic. Ho l’impressione che anche questa esigenza di raccontare la vita di Pirandello, la vita di Caravaggio, eccetera, sia un impoverimento della narrazione. Forse sto raccontando la vita di quel personaggio perché non ho nient’altro di cui parlare. Per un’opera di narrativa bisognerebbe andare a capire in cosa consista il dato reale, visto che l’elemento di fiction e di non fiction si toccano talmente da vicino che diventa complesso capire cosa sia frutto dell’invenzione e cosa non lo sia. Molto spesso trovo ci sia questa esigenza, probabilmente che parte da un pubblico e da un mercato, di voler trovare il dato reale anche nei confronti del romanzo storico. Ti fanno le pulci anche quando è superfluo, visto che si tratta di un romanzo, non si tratta di una monografia, di un manuale di storia. Questa esigenza allora bisognerebbe declinarla anche nei confronti della storia della letteratura. Bisognerebbe interrogare i nostri predecessori e chiedere se tutto quello che hanno raccontato nelle loro novelle, nei loro romanzi fosse reale. Loro cosa risponderebbero? Cosa vuol dire reale?
Quando penso al reale penso a un’osservazione del mondo che ci circonda attraverso il filtro della nostra personalità, del nostro trascorso, quindi che include chi siamo, da dove veniamo, quale sia il nostro status. Questi fattori vanno a condizionare quello che è il mio punto di vista sulla realtà, contamina quello che scrivo e il lettore non lo accoglierà con la stessa forma in cui l’ho concepito. Dal momento in cui penso (o scopro) ciò che voglio scrivere e la parola raggiunge il lettore sono avvenuti diversi passaggi e manipolazioni, sono stati applicati una serie di filtri. La somma di questi filtri non ci allontana dalla realtà da cui siamo partiti? Maupassant scriveva: “se è un artista, il realista cercherà non tanto di mostrarci la fotografia banale della vita, quanto di darci una visione più completa, più intensa, più probante della realtà stessa”. Se vogliamo, abbiamo bisogno della menzogna per raccontare la verità o per raccontare, sarebbe meglio dire, la nostra visione della verità.
Andrea:
Sì, assolutamente. Noi illudiamo di fatto il lettore nel momento in cui scriviamo un memoir, un romanzo storico, un reportage, illudiamo un lettore di compiere un’operazione di rappresentazione della realtà, invece stiamo inserendo all’interno della nostra narrazione tutta una serie di contaminazioni fiction. Questo non lo facciamo solo quando scriviamo, lo facciamo anche quando raccontiamo un aneddoto: se io chiamo mia madre e gli dico che stamattina affacciandomi alla finestra ho visto un incidente, nel farlo inconsapevolmente inserirò degli elementi fiction. Perché lo faccio? Lo faccio per abbellire la storia, per renderla più funzionale. Lo abbiamo ereditato dai greci, ce l’abbiamo nel nostro DNA. Trovo assurdo scrivere che è tratto da una storia vera, perché dovremmo paradossalmente mettere una percentuale, per il 15% è tratto da una storia vera e per il resto è una fiction, oppure il contrario, perché l’intervento dell’invenzione c’è sempre quando noi scriviamo. Alla fine, il realismo e la finzione sono sempre esistiti, parliamo sempre della stessa cosa che rinominiamo ogni volta con un nome diverso.
Perché sentiamo il bisogno di raccontare il reale? Significa scrivere per comprendere la realtà, per fare denuncia, criticare gli aspetti della società? Se questo è vero allora quale dovrebbe essere il ruolo dell’autore? Può essere quello di vigilantes dello stato di salute della democrazia, oppure di analista di laboratorio della materia umana, della materia sentimentale e sociale? Ancora, lo scrittore può avere un impegno, una funzione sociale, di osservazione sociologica, politica, visto che oggi viene talvolta richiesto all’autore di essere schierato, di avere un’opinione sulla realtà circostante?
Andrea:
Secondo me questa questione qui è strettamente legata a una questione politica, ma nel corso della storia, i famosi corsi e ricorsi storici, l’alternanza tra vero e fantastico, chiamiamola così genericamente insomma, una grossolana divisione dei due campi, è sempre stata dettata dalle circostanze storiche, storico-politiche. Nei momenti di stretta sulla libertà di parola per esempio vince la fantasia, pensiamo ai romanzi sudamericani degli anni ’70, il realismo magico che fiorisce in contesti dittatoriali terrificanti. In epoca di maggiore libertà di espressione di parola o in cui ci sono delle congiunture sociali particolari come la nostra, la realtà è più richiesta. Perché è più richiesta? Pensiamo all’avvento dei social. I social sono una forma di narrazione del sé che ha riposto al centro l’io come non era mai stato fatto prima. Il social richiede l’abilità di scrittura. Negli anni ’90 non si scriveva. L’uso della scrittura era riservato solo a certi ambiti. All’improvviso intorno alla fine degli anni ’00 comincia ad essere richiesta di nuovo la capacità di raccontarsi. Farlo per quello che si è, o meglio, per quello che si vorrebbe essere o per quello che vorremmo essere agli occhi di chi ci sta guardando dall’altra parte. Questa è fame di realtà, è da lì che arriva il bisogno di essere veri. Ma è una verità discutibile, è uno specchio, un sogno, chiamiamolo come vogliamo, resta il fatto che questa roba qui è sempre comunque legata a contingenze storico o sociali. Il fatto che agli scrittori di oggi venga chiesto di dire la loro sui temi contemporanei, come se fossero chiamati ad essere critici o comunque vigili sulla realtà, c’è sempre stato. L’intellettuale dovrebbe essere quello. A me quello che fa orrore oggi – e lo dico senza tema di smentita – è la necessità che i miei colleghi scrittori sentono di essere moralmente ineccepibili. E su questo apriamo un altro capitolo: c’è questa richiesta da parte del lettore, ma che comunque è anche una necessità che sente lo scrittore di mettersi in posa da prete benedicente e di stare sempre dalla parte moralmente giusta. Io che anagraficamente appartengo a una generazione precedente alla vostra, ho fatto in tempo a vedere ancora degli intellettuali, degli scrittori, dei registi che invece se ne fregavano e andavano contro la morale dominante. Avevano le spalle abbastanza larghe per sostenere anche un’opinione discutibile per non essere dei modelli almeno apparentemente di virtù anche nella vita privata e tutte queste questioni secondo me sono strettamente intrecciate rispetto al discorso che stiamo facendo.
Maddalena:
Questa riflessione mi pone un’altra domanda, mi fa riaffiorare la stessa che spesso, io e te, Simone, ci poniamo nelle nostre disquisizioni private, e cioè se tutto questo non voglia dire che esista una sorta di dittatura del pensiero, se in qualche modo abbiamo creato una forma di “dittatura” – è un termine che può essere spogliato anche della sua accezione più puramente politica, anche in questo contesto –, proprio all’interno di uno spazio, di un mondo, che dovrebbe essere ciò che più è distante da questo, dal dato politico, e ancor di più, dal dato “dittatoriale”. Trovo che l’intellettuale, lo scrittore, non debba, oggi più che mai, ricoprire questo ruolo, né rischiare di cadere nelle stesse dinamiche che poi critica con la stessa penna con cui contribuisce a metterle in essere.
Ho un po’ di ritrosia nei confronti della parola dittatura. Non l’ho mai conosciuta da vicino, per fortuna, e ho paura di non darle il giusto peso. Avverto senz’altro una pressione, questo sì, ma lo vedo attorno. La si respira nella nicchia, anche se non tutti ne fanno un cruccio. Ho avuto modo di parlare anche con persone che hanno un’esperienza centrale nel panorama letterario italiano e hanno lamentato la presenza di questa pressione, una pressione che qualcuno sceglie di assecondare, qualcuno di ignorare, ma che crea una discussione all’interno della bolla. Per questo mi piacerebbe chiedervi, visto quello che ha detto Andrea, se c’è questa necessità di essere moralmente ineccepibili, cos’ha portato questa necessità? Come si riflette nella carriera di un autore, adesso che la reputazione è importante e il social è vigile, con l’indice puntato in attesa di un passo falso, ora che si sente la paura di cadere nel dimenticatoio in uno schiocco di dita?
Andrea:
Quella che tu definisci pressione ha un mandante, un unico mandante che è il mercato. È il mercato che richiede un certo tipo di romanzi e tu ti devi adeguare se vuoi vendere. La faccio proprio semplice: quel mandante lì, chiamiamolo capitalismo, come vogliamo, ma è da lì che poi deriva a cascata tutto il resto. C’è chi decide di non assecondare il gioco del mercato, anche se ci pensiamo tutti quando cominciamo a scrivere che il libro diventerà un prodotto. Quando faccio i miei corsi di scrittura ai miei allievi, invito a non avere paura di pensare che il loro libro diventerà un prodotto commercializzato. Questa è la società in cui viviamo. Sul “cadere nel dimenticatoio”: tu produci un romanzo, quel romanzo gira, se va bene, tre mesi. Se va benissimo ne gira sei, se va proprio di lusso gira un anno e dopo un anno uno finisce nel dimenticatoio, per scriverne un altro passano due o tre anni, se va bene, in quei due o tre anni tu devi alimentare il tuo nome. Quindi cosa fai? Cerchi di essere presente sulle piattaforme, sulle riviste culturali, cercando di alimentare il dibattito. Un tempo per essere visibili si provocava. Sono cresciuto con Irvine Welsh, con Bukowski, che provocavano non perché volevano essere presenti nel dibattito, ma perché erano così. Irvine Welsh, al quale ho dedicato un piccolo saggio di recente, oggi è irriconoscibile perché opera quelle stesse furberie che operano un po’ tutti pur di essere accettati moralmente dal pubblico di riferimento. I tempi cambiano e anche gli autori a un certo punto cambiano. Essere al centro di questo meccanismo però è un gioco al massacro, perché cercare di cavalcare l’onda significa che prima o poi verrai comunque sbalzato giù, c’è poco da fare. Bene che ti va riesci ad avere una visibilità che dura ventiquattro ore quando azzecchi il post giusto che viene condiviso da un migliaio di persone. Per fare questo vendi te stesso, tua madre, tua sorella, tuo fratello, quello che sei intimamente, cercando di apparire per quello che non sei, perché io non posso credere che tutti gli scrittori italiani contemporanei, per rimanere nell’ambito italiano, siano così ineccepibili nella vita. Siamo tutti esseri umani. Io preferisco un essere umano, un figlio di puttana, uno che fa delle cazzate, perché siamo così, eppure a giudicare dalla bolla letteraria, a sentir parlare gli scrittori contemporanei, siamo tutti delle suore.
Maddalena:
Sono perfettamente d’accordo con tutto questo. Se vogliamo riferimenti pop, a Sanremo abbiamo celebrato un Lucio Corsi. Improvvisamente tutti abbiamo scoperto Lucio Corsi, che è la voce fuori dal coro, la pecora nera, quello che si vestiva da solo, quello che aveva studiato veramente musica, quello che in qualche modo aveva qualcosa da dire, qualcosa da scrivere. Forse anche quella è stata un’esigenza personale, qualcosa di cui noi avevamo bisogno, perché tutti ci siamo rotti le scatole dell’appiattimento verso un’unica forma musicale, un’unica forma letteraria, un’unica espressione. Mi chiedo se sia però davvero una rottura o figlio di quegli stessi schemi. Quando l’ho visto da Fazio ho tremato, perché Fazio rappresenta l’allineamento al pensiero moralmente corretto, alla parola giusta.
Non ci allontana dalla realtà il bisogno di essere allineati? Diventa difficile esprimersi perché non si capisce quanto ci si possa sbilanciare. Se siamo di sinistra, guai a usare terminologie o portare ragionamenti che richiamano la destra. Rischieremmo di non aderire più agli schemi della sinistra. Stessa cosa a parti inverse. Non parlo solo di politica, ma di punto di osservazione della realtà in cui non viene riconosciuto il valore della sfumatura. In una scena letteraria in cui il mercato richiede una nostra partecipazione, un posizionamento, c’è un modo per tornare alla realtà o svignarsela, come Salinger che fugge dai riflettori e si ritira dalla vita sociale? C’è un modo per affrontare questa situazione senza fuggire dal sistema?
Andrea:
Questa è una bella domanda. Il ruolo di provocatori che potevano avere gli intellettuali un tempo era riferito allo scenario politico. Se penso agli anni ’70 c’erano uomini della democrazia cristiana, che apparivano al telegiornale la sera, e il potere era questa maschera apparentemente ineccepibile. Poi c’erano Pasolini e Bellezza, intellettuali che facevano dello scandalo la loro cifra culturale. Oggi siamo circondati da politici scandalosi che dicono cose scandalose che spostano sempre un metro più in là la soglia della tolleranza. L’intellettuale prova a mantenere ancora la lucidità, a evitare gli sbilanciamenti troppo a destra e a sinistra, ricorda che dobbiamo essere noi i soggetti pensanti in questo mondo che fa dei distinti più feroci la sua cifra di competizione. A me viene in mente un autore come Houellebecq che se ne frega di tutto questo. Lui è uno che fotografa questa società oscena, allo sbando, e nella vita supera ogni risposta moralistica mirata alla sua persona. Giusto? Sbagliato? Secondo me bisogna uscire da questa logica, bisogna smettere di giudicare le persone e giudicare le opere. Uscire dalla mischia. Anche se, voglio lanciarvi una provocazione, siamo già tutti fuori dalla mischia. Anche il più importante scrittore italiano vivente (che non so chi sia) è qualcuno che tra un mese non sarà più su quel trono. Il ruolo centrale, dettare l’agenda culturale del paese, è una cosa che non fa più nessuno. Siamo tutti fantasmi destinati a svanire perché è destinato a svanire lo strumento culturale dalla scena. Non ci dobbiamo nemmeno affannare a cercare una modalità di presenza-assenza, perché siamo già destinati culturalmente alla morte. Il mandato della letteratura nel corso dei secoli, in questo periodo storico, è residuale. Facciamo un mestiere che non sposta una virgola nell’economia del mondo. Sono cose brutte da dirci, perché noi facciamo di questo anche una ragione di vita, ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Sopravvivere in una situazione come questa significa trovare un orticello dentro un bunker quando là fuori è già scoppiata l’atomica.
Maddalena, tu sei d’accordo con la visione di Andrea?
Maddalena:
Abbastanza. Mi è bastata l’ultima presentazione nella ridente Terni nella quale mi sono rinchiusa, per vedere che c’era un confine tra l’interno della biblioteca dove si teneva la presentazione e l’esterno. Fuori c’era una marea di gente a fare aperitivo e dentro quattro vecchietti che non avevano trovato posto alla sala medica della dottoressa, in attesa che si liberasse il posto per fare la visita. Questa è la realtà, non bisogna stupirsi. Soprattutto la nostra generazione dovrebbe essere consapevole che stiamo facendo un’opera di salvataggio di qualcosa che forse non si può salvare.

Con questa iniezione di fiducia penso che andrò a farmi un cocktail di cianuro (annaspo, sfogliando gli appunti, ridendo e cercando di uscire dallo stato di evidente annichilimento).
Andrea:
Oh, sono contento di averti messo in crisi.
(Dopo un breve fuorionda, torniamo alle domande)
La settimana scorsa parlavo con Federico Riccardo, che è amico e collega, e ci stavamo interrogando su quali possano essere i limiti di pubblicare con la sua rivista (in futuro casa editrice) unicamente testi contemporanei. Gli ho chiesto: se tiriamo su un piano una riga che rappresenta l’insieme di pubblicazioni dall’anno 2023 all’anno, per esempio, 2050, guardando tutte le opere che analizzano il contemporaneo avremo una visione complessa e sfaccettata della realtà che abbiamo vissuto. Ognuna osservata dal punto di vista degli autori che hanno pubblicato in ordine cronologico. Ci siamo risposti che il limite possa consistere nella durabilità di un’opera nel tempo, cioè quanto possa considerarsi eterna, perché un’opera che analizza il presente (o il passato dell’altro ieri o il futuro imminente) può considerarsi circostanziale al periodo temporale che racconta, e quindi superabile e superata già da domani. Può però renderla eterna il suo linguaggio, lo stile: a superare la prova del tempo è lo stile, non il tema. Vista a posteriori, quali sono i vantaggi di raccontare il contemporaneo e quali altri limiti ci sono?
Andrea:
Venerdì sera, dopo che tutti abbiamo iniziato a discutere dell’agguato in diretta di Trump a Zelensky e vediamo le dinamiche politiche cambiare sotto i nostri occhi in trenta secondi, comincio a vedere una serie su Netflix. Mi becco Robert De Niro [si riferisce alla serie Zero Day] che è l’ex presidente americano. Il paese è sotto attacco hacker: niente elettricità, le metro vanno a schiantarsi, migliaia di morti. Istituiscono una commissione che limita le libertà personali e incaricano questo ex presidente, interpretato da De Niro. Tutti si scagliano contro i russi, eccetera. Ecco, quella è una serie appena caricata sulla piattaforma, ma è già radicalmente vecchia per la rappresentazione che fa del potere americano, degli equilibri del mondo. Un prodotto che sarà stato pensato nel 2024, ma che è già vecchio, perché è stato superato da quei trenta secondi di quel venerdì sera. Questo è il rischio di trattare la realtà. Seconda cosa: siamo sicuri che la realtà entri così prepotentemente nel mainstream culturale? Perché se vado in libreria tra le ultime novità, i romanzi sono ambientati nella seconda guerra mondiale con protagoniste donne in difficoltà che subiscono violenza dagli uomini o dalla storia, copertine con orizzonti polverosi, di guerra, la lotta per il pane, la fame. Si fugge dalla contemporaneità dislocando nel passato i temi più urgenti del presente. Qualche tempo fa c’è stato un articolo di Rivista Studio in cui ci si chiedeva perché gli scrittori non affrontano temi contemporanei. Ci ha provato Paolo Giordano con Tasmania, che è un titolo forte. Quando c’è stata la pandemia si diceva che tutti avrebbero scritto della pandemia. Quanti romanzi sono usciti che parlano di pandemia? Forse un paio. Noi stiamo facendo questo discorso sulla contemporaneità, sul reale, ma non è che forse è uno specchietto per le allodole e in realtà – scusate il gioco di parole – facciamo di tutto per scappare dalla realtà fingendo di affrontarla infilandola in ogni cosa che facciamo? Non è che forse abbiamo una paura fottuta di affrontarla rifugiandoci in vecchie storie che strizzano l’occhio al mercato, che hanno maggiore presa, ma da un punto di vista letterario non ce ne frega nulla?
Maddalena:
Ottima osservazione. Sembra che ci sia un campionato di serie A e uno di serie B su questi temi. Quali sono i temi che bisognerebbe coraggiosamente affrontare da un punto di vista letterario? Ce ne sono alcuni che vengono spinti in maniera più o meno riuscita, più o meno coraggiosa. Come il discorso della violenza sulla donna, ad esempio. Poi ci sono altri temi, magari scomodi, che guardando la narrativa contemporanea, non vengono affrontati. Penso a 25 di Zannoni, che alcuni hanno stroncato, perché veniva da I miei stupidi intenti che era un’esperienza fantastica, quasi Disney italiana, bellissima. Lui ha affrontato, secondo me, con giusto piglio una fase precisa della vita giovanile con risvolti attuali, e molte persone attorno a me non l’hanno apprezzato. Allora mi chiedo: come dobbiamo affrontare questi temi? Perché io questo essere impavidi nell’affrontare certi temi lo vedo poco.
Su questo concordo con te. Io penso che in questi anni ci sia stato qualche tentativo. Penso a X di Valentina Mira, che ha tratto in maniera forte la questione della violenza di genere, tanto che è un libro che vive ancora, per fare un esempio. Di libri che parlano di violenza sulle donne, di diritti delle minoranze, di pride nel senso largo del termine, di immigrazione (tema che ha generato molti libri nel periodo in cui se ne parlava di più in tivù, sui giornali), ce ne sono. Per non parlare del filone dell’analisi generazionale. Per un certo periodo sono stati pubblicati romanzi e antologie sui boomer, sui millennial, sulla GenZ. Ma l’impressione è che ci fosse una sorta di uniformità delle tematiche. Ci saranno almeno dieci romanzi sui millennial o della GenZ che parlano di precarietà, di rivalutazione del rapporto di coppia o di rapporto con i social. Ma non sono gli unici temi che ci rappresentano. Mancano rappresentazioni eterogenee nel linguaggio, nello stile e nella ricerca del tema comune, ma meno battuto.
Sono diminuiti i libri sul razzismo e sul fenomeno migratorio perché se ne parla meno. Sono aumentati invece quelli di orgoglio femminile, di violenza di genere, perché è un tema caldo del dibattito pubblico. Sotto alcuni post di Instagram di Einaudi si leggono critiche sulla scelta di pubblicare testi che strizzano l’occhio alla cultura femminista, vedi l’ultimo libro di Francesco Piccolo, perché sembra esserci la volontà di raccontare la realtà attraverso il punto di vista della propria lente, ma senza l’intenzione di rischiare di uscire dal seminato. È giusto parlare di violenza sulle donne? Certo che lo è. Giusto parlare di diritti delle minoranze? Ovviamente sì. Ma manca quel punto di vista da underdog, lo sguardo anticonformista che è davvero tale. Manca forse una penna, o una serie di penne, che provi a parlare della realtà senza portare con sé le bandiere, che non scriva per compiacere un pubblico o per scrivere la verità in senso assoluto, ma che dica, attraverso la finzione di cui si avvale la narrativa, la sua visione della realtà.
Andrea:
Giusto. Nessuno mette in discussione l’importanza di questi temi, anche dei temi più caldi che sono al centro di narrazioni vincenti oggi. Ma noi cosa vogliamo fare? Vogliamo dire al lettore quello che vuole sentirsi dire o vogliamo metterlo in crisi? Da lettore, i libri che preferisco sono quelli che mi mettono con le spalle al muro. Anni fa ho avuto il piacere di conoscere Abraham Yehoshua, con cui ho passato dei giorni, e mi ha fatto lezioni sulla letteratura che non dimenticherò mai. Mi diceva: cosa differenzia un grande romanzo da uno mediocre? Il dilemma morale. Lui insisteva su questo. Per dilemma morale intendeva un elemento della storia, del comportamento dei personaggi, che sfuggisse a ogni possibilità di catalogazione, che mettesse il lettore con le spalle al muro. Come faccio a giudicare il comportamento di questo personaggio con i miei standard morali? Non posso farlo, quindi sono sotto scacco. Le grandi opere sono così. Lo straniero di Camus, un esempio massimo. Faccio tesoro di questa lezione. Anche prima, quando ti sei mostrato in crisi, ecco, io sono contento quando metto in crisi qualcuno. Sono contento anche di andare a parlare di grunge a un pubblico di ottantenni, perché non sono un elemento consolatorio. Invece vedo un grande successo tra i miei contemporanei perché dicono la frase giusta al momento giusto, la cosa che la platea vuole sentirsi dire, sia durante la presentazione sia durante le interviste o al Salone del Libro o da Fazio. Io sono contro la narrativa consolatoria. La postura dell’intellettuale deve essere destabilizzante, mai accomodante.
Maddalena:
Sono d’accordo su tutto. Io ho fatto la Scuola Holden, ho ricordi positivi e negativi e penso sia vero che ci sia un appiattimento dovuto a quello che richiede il mercato. Si richiede all’autore di accelerare a scrivere, come se fosse una cosa meccanica, come se bastasse la monetina del jukebox. Si è persa l’esigenza di osservare la volontà dell’autore, cioè lasciare che l’autore racconti la storia proprio come vuole. Anch’io ho respirato questa atmosfera. Vai a questo Opening Doors (che non è altro che un incontro con gli editori), che sembra l’occasione della vita se no sei spacciato, e poi vengono premiati solo quelli che scrivono “certi” libri, con “certi” temi, e un “certo” stile, che rispondono alle esigenze di molti nostri maestri della scuola. Io ovviamente sono stata bocciata, quando ho presentato il mio romanzo. L’ho presa molto male, poi ho pensato che se mi hanno bocciata forse qualcosa di buono ho scritto, perché sono andata contro la richiesta media di quel momento.
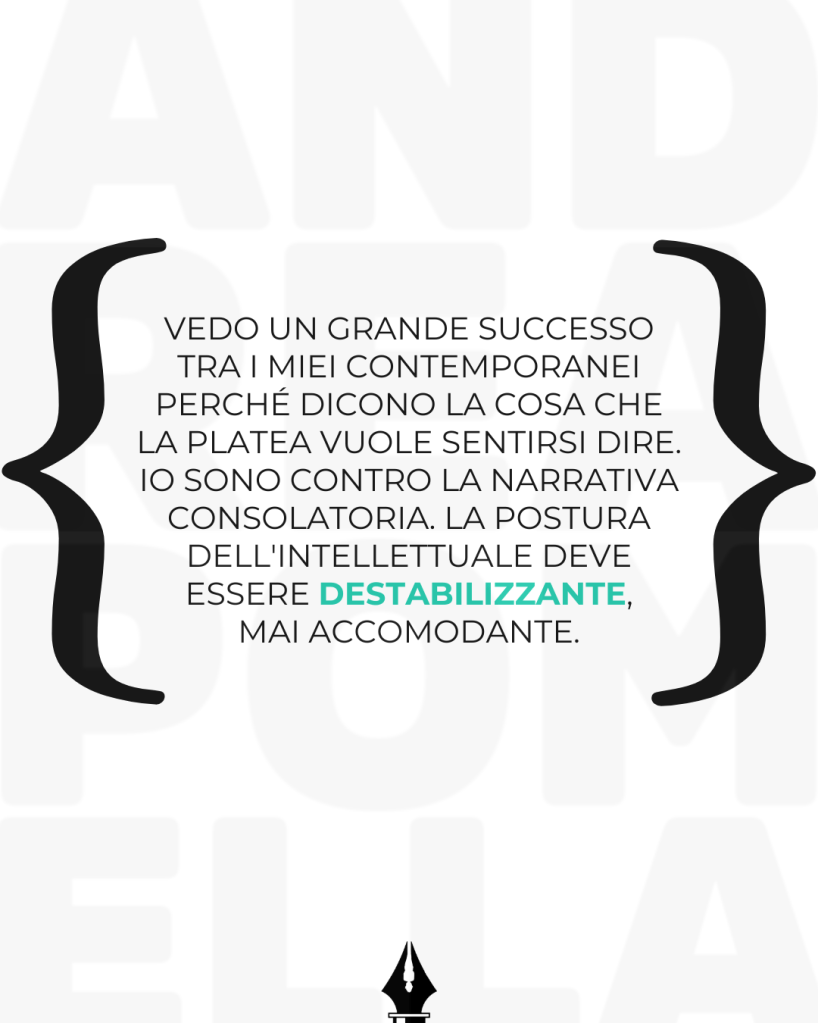
Forse abbiamo bisogno di essere messi con le spalle al muro perché ci interessa capire noi stessi e capire la realtà che ci circonda proprio perché inafferrabile. Anch’io vedo il post acchiappalike, l’aforisma ben congeniato che fa scattare l’applauso alle presentazioni, mossa anche astuta che ci permette di aumentare il nostro cachet reputazionale. Mi chiedo genuinamente perché questa cosa sia accettata tra noi autori. Da una parte abbiamo il bisogno di essere riconosciuti dal settore e poter fare vendere il nostro libro, dall’altra c’è la necessità di essere autentici – termine ambiguo, perché o si vede nell’opera o nella tua comunicazione sui social, alle fiere e via dicendo. Voi ci pensate mai alle aspettative del lettore, degli addetti ai lavori o alle vostre?
Maddalena:
Alle mie molto. A quelle degli altri ho imparato a non dare retta, non per superbia, anche se ci sono dei buoni consiglieri. Per il mio primo romanzo non ho voluto sapere quanto ho venduto, perché non mi interessa. Può essere rilevante da un punto di vista economico, ma non mi sposta rispetto a quello che sto scrivendo o scriverò. C’è stato chi mi consigliava di scrivere in un certo modo, mi diceva di “fare questo e quello e poi vediamo”, ma a me non interessava. Se vendo poco non importa, lo regalerò al Conad. Non trovo il senso di scrivere con la pistola alla tempia perché altrimenti sarei un’autrice spacciata. Preferisco essere spacciata che scrivere a queste condizioni.
Andrea:
Io personalmente non ho mai subìto influenze di questo tipo. Vero è che ho passato decenni a scrivere una marea di cose ed essere puntualmente rifiutato da tutte le principali case editrici italiane, compresa Einaudi, che poi mi ha accolto nel suo catalogo. Einaudi ha sempre avuto fiducia nelle mie proposte. Ho sempre goduto della massima libertà e non ho mai ricevuto pressioni da loro. E questo per uno scrittore come me credo sia una precondizione, dato che non sarei in grado di scrivere una cosa perché tira, anche perché, come dicevamo prima, quello che tira adesso non tirerà tra sei mesi, e il libro che uscirà tra un anno sarà già preistoria. Concordo con Maddalena che bisogna fregarsene. Parliamoci chiaro: ci vuole anche una componente di culo nell’avere successo. Penso di nuovo a Houellebecq, che io stimo molto come scrittore, che esce con Sottomissione nel giorno dell’attentato a Charlie Hebdo. Mi rendo conto che sia orribile parlarne in questi termini, ma è stata una coincidenza a lui favorevole. Il tempismo fa molto, ma non te lo insegna nessuno, è imponderabile. Io ho sentito veramente da tanti scrittori questa frase: sto scrivendo un romanzo per il Premio Strega. Una cosa che a me fa venire i brividi. Io ho partecipato allo Strega, mi sono divertito e non lo nego, ma scrivere per un obiettivo del genere è pura follia. Io sono convinto che si debba fare la propria strada e fregarsene di tutto. Vada come vada.
Che sia attraverso l’autofiction o no, vi sembra che la letteratura contemporanea stia raccontando la realtà o stia cercando di modellarla, di educarla?
Andrea:
Significa che io metta me stesso come paradigma migliorativo del mondo. Mi viene da ridere al solo pensiero. Secondo me c’è un equivoco grave di fondo quando si parla di scrittura autobiografica. In genere i detrattori di questo genere usano un aggettivo che denota tutta la loro ignoranza in materia, cioè “ombelicale”. Come se parlare di sé fosse un’operazione narcisistica. In realtà questo genere, come ci insegna una maestra, Annie Ernaux, non è la scrittura dell’io ma la scrittura del noi. Se scrivo di me e di quel tema è perché penso che la mia esperienza possa riguardare una grande comunità di persone. Può essere un’esperienza generazionale, un viaggio, una malattia, quello che volete. Se non c’è questo passaggio, c’è altro. Qualcosa che forse non ha a che fare con la letteratura. A proposito de L’uomo che trema mi chiedono come abbia fatto a mettermi così a nudo. Io rispondo che non l’ho fatto, ho cercato piuttosto di mettere a nudo i lettori. A me non importa mettermi a nudo quando scrivo, anzi, indosso una corazza ancora più dura di quella che indosso quando esco di casa per fare una passeggiata. Questa è un’incomprensione grave: quando D’Adamo ha vinto lo Strega si sono scagliati contro la narrativa del dolore. Ho sentito un famoso scrittore italiano di fiction dire: diciamoci la verità, a chi importa di sentire i cazzi miei? A chi dovrebbe interessare? Io credo che ci siamo interessati dei cazzi di Proust, fino a prova contraria..
Maddalena:
L’elemento autobiografico dipende dallo stile. Ricordo di aver visto un estratto di Marracash in cui parlava di rapper che non vengono da un contesto di strada, di povertà, di malessere, e che fingono di ritrovarcisi. Proseguiva dicendo che non è detto che chi viene da un contesto borghese non abbia qualcosa da raccontare. Anche la borghesia ha il suo malessere. Perché Marracash ha avuto successo? Perché racconta in maniera credibile ciò che ha vissuto. Qui la scrittura trova il suo sfogo, e secondo me il lettore sa quando ciò che scriviamo è autentico e quando è costruito per accalappiare un certo tipo di pubblico per dovere di un’operazione commerciale.
Riprenderei la parola “educazione” perché in questo periodo storico si sta attribuendo all’educazione, all’aspetto culturale, un ruolo fondamentale della buona riuscita o del fallimento di alcuni aspetti della società. Negli ultimi anni hanno fatto discutere le scelte di alcune università del mondo anglosassone, le quali hanno rimosso dalle biblioteche e dagli oggetti di studio alcune opere di Shakespeare o Virginia Woolf o Dickens perché contenevano parole offensive verso la comunità nera o perché parlavano di abusi, di violenza. Dal mio punto di vista, raccontare la realtà non dovrebbe avere una funzione educativa. Lo scrittore può, ma non deve avere il compito di educare, di stendere sul foglio la sua morale, perché il rischio potrebbe essere quello di fare della letteratura uno strumento di rappresentazione di bontà a senso unico, di consolazione. Una letteratura catechetica e per chi aspira al paradiso. Invece la letteratura potrebbe prendersi la libertà di raccontare i vicoli bui o i vicoli ciechi, a volte anche con mezzi poco ortodossi. Anche perché la realtà, anche quella più inaccettabile, ha un valore storico che non deve essere oscurato né dimenticato. Superata la fase di polemica iniziale contro la cancel culture, come vi sembra che venga trattata oggi la narrazione della “cruda realtà”?
Andrea:
In un mondo in cui la famiglia non educa, la scuola non educa, la politica fa tutto fuorché educare, perché questo compito ce lo dobbiamo prendere noi sulle spalle? Educare a cosa? Educare è un compito che storicamente non si attribuisce alla letteratura. L’autofiction a cui penso è quella di Walter Siti. Io voglio parlare delle cose che valgono, non di quelle che non valgono. Quella di Siti non ha nessun intento educativo. Perché devo essere io a educare un lettore, se prima non è stato educato dai genitori, dai professori, e via dicendo?
Ho posto questa domanda perché mi è parso di riscontrare degli effetti sul mercato. Il mercato promuove – anche – un certo libro perché ha un valore sociale, definito educativo. Non sto parlando di libri di pedagogia o di divulgazione scientifica, parlo di romanzi: perché un romanzo dovrebbe essere svolgere il lavoro di un’insegnante o di un genitore? Mi chiedo perché siamo arrivati al punto di domandarci del valore educativo o morale di un’opera, e come abbiamo permesso che alcuni di essi diventassero casi editoriali. Prima Andrea hai detto “Io voglio parlare delle cose che valgono” e sono d’accordo, ma io voglio anche parlare di quelle che non valgono, se queste condizionano il mercato e il pensiero del lettore medio, soprattutto in un’epoca in cui il social premia ed esalta proprio il disvalore. Mi chiedo, in ultima battuta, come mai diventino oggetti di studio alcuni libri e non altri.
Maddalena:
Se provo a pormi io come filtro educativo penso: siamo messi male. Io non devo e non voglio ricoprire questo ruolo. Questo non toglie che io sia una mente pensante e abbia delle opinioni che possa esprimere in diverse sedi. Chi si arroga il diritto di essere educatore mediante la propria arte magari è lo stesso che parte a scrivere pensando già di vincere lo Strega.
A questo punto della chiacchierata, chiedo sempre ai miei ospiti di pensare all’editoria e di provare ad accennare della sana autocritica. Quale aspetto dell’editoria vorreste cambiare? Quale invece vorreste che rimanesse fedele nel tempo?
Andrea:
L’aspetto che vorrei cambiare è questo sentirsi una bolla, una sorta di elitarismo percepibile. “Noi sappiamo cos’è giusto e sbagliato, cosa sia giusto fare, quanto sia osceno quello che succede là fuori”. È tutta apparenza, chiaramente. È l’atteggiamento che è stato disgrazia della sinistra, ovunque. La destra la definisce “la presunta superiorità morale della sinistra”. Peccato che la superiorità della sinistra non fosse presunta, ma fosse reale, di questo ne sono convinto. Ora però ci è rimasto solo quello. Questo si esprime nella bolla editoriale in maniera amplificata. Mi piacerebbe cambiare questo, iniziando a fare i conti con la realtà uscendo dai lingotti, dalle nuvole, facendo parte del mondo. Qualcosa che vorrei rimanesse così com’è: i libri. Il libro è un oggetto immutabile, con parole scritte nere su bianco, che però è capace di farci stare qui a discutere per un’ora e mezza. È una delle più grandi invenzioni dell’umanità, specie in momenti di grande incertezza in cui anche le certezze più granitiche vengono meno.
Maddalena:
Vorrei che fosse lontana dall’editoria la logica di potere secondo cui se tu sei amico di qualcuno allora vali la pena di essere letto e pubblicato; se sei in classifica o hai partecipato a quel premio sei meritevole. Non ha niente a che fare con la creatività, la scrittura, le idee, il confronto. La competizione, un’altra parola che terrei fuori. Vorrei che restasse tale la passione: nonostante il cinismo non ci fa mollare e darla vinta a chi vorrebbe solo questo tipo di produzione letteraria.
Il vostro ricordo più memorabile e il più trascurabile della vostra esperienza editoriale.
Andrea:
Un ricordo bello, ma anche molto doloroso. Una volta stavo al carcere di Napoli, per il Premio Napoli a cui partecipavo con L’uomo che trema. Alla fine della presentazione un detenuto si è avvicinato e mi ha detto: “fuori di qui ho una compagna con depressione grave. Io ho una condanna a sedici anni di carcere e ho il terrore di non ritrovarla più quando esco. Cosa posso fare?”. Il detenuto mi ha posto questa domanda mentre l’agente lo strattonava, invitandolo a tornare in cella, che non c’era tempo. Davanti a questa domanda mi sono trovato spiazzato, incapace di rispondere, e lì ho capito tutto il limite dell’essere scrittori. L’impossibilità di dare risposte che servono, soprattutto nella vita concreta. E nonostante sia un ricordo spiacevole, io lo ricordo come qualcosa che mi ha rimesso in testa chi sono e che cosa voglio fare con la scrittura. Non sono una persona che può essere utile nel quotidiano, specie per persone che hanno difficoltà di questo genere. I libri sono una cosa, la vita è un’altra.
Il ricordo peggiore è durante una presentazione durante la quale interviene il sindaco, poi l’assessore alla cultura, poi il primo relatore, che passa la parola al secondo relatore, che era docente all’università, dopodiché di nuovo al primo relatore, si passa la palla al comitato e l’incontro finisce: grazie e arrivederci. Non ho detto una parola perché dovevano esibirsi i politici del paese. Questa è la cosa più deprimente e oscena del fare viaggi e portare in giro i libri.
Maddalena:
Ricordo più spiacevole, una delle prime presentazioni che avrei dovuto fare, nella mia città, è iniziata con una telefonata da parte del mediatore, che mi dice, a distanza di un paio di giorni, che le copie del mio romanzo non se le era procurate, e che il romanzo non l’aveva letto. Credevo fosse uno scherzo – di pessimo gusto –, invece era la realtà. Ho declinato l’invito, più o meno elegantemente.
Il mio ricordo migliore ha come protagonista mia nonna. Lei ha comprato il libro e lo ha letto. Quando sono andata a trovarla mi ha detto: ero sicura che avresti scritto qualcosa, però, sai, non ricordo niente di quello che ho letto ma giuro che lo rileggo. Sai, mia nonna ha 95 anni. Adesso credo che sia la quarta volta che lo rilegge.
Il nostro bisogno di realtà – Dialogo con Andrea Pomella e Maddalena Crepet è il terzo appuntamento di {dis}impegno letterario, una rubrica a cura di Simone Sciamè.

Andrea Pomella è nato a Roma nel 1973. Dopo aver pubblicato tra il 2004 e il 2007 monografie d’arte su Caravaggio, Van Gogh e i Musei Vaticani, esordisce nella narrativa con Il soldato bianco (Aracne, 2008). Ha pubblicato poi i romanzi La misura del danno (Fernandel, 2013), Anni luce (Add, 2018; entrato lo stesso anno nella dozzina dello Strega), L’uomo che trema (Einaudi, 2018; vincitore del Premio Napoli 2019 e del Wondy 2020), I colpevoli (Einaudi, 2020) e Il dio disarmato (Einaudi, 2022). Suoi sono inoltre i saggi narrativi 10 modi per imparare a essere poveri ma felici (Laurana, 2012) e A Edimburgo con Irvine Welsh (Perrone, 2023). Il suo ultimo romanzo è Vite nell’oro e nel blu (Einaudi, 2025). Insegna alla Scuola del Libro di Roma e alla Scuola Holden di Torino.

Maddalena Crepet (Roma, 1994) si è laureata in Storia contemporanea con una tesi sul tentato omicidio del professor Sergio Lenci da parte della banda armata Prima Linea, avvenuto nel 1980. Ha frequentato il corso biennale Scrivere presso la Scuola Holden di Torino. Rientrata a Roma, lavora come ufficio stampa e consulente editoriale. Ci siamo traditi tutti (Solferino, 2024) è il suo primo romanzo. Ha all’attivo diverse pubblicazioni di racconti per riviste letterarie. Per «L’Appeso» ha scritto il racconto Non amo che le rose (in anteprima su L’Appeso Numero 6).
Vuoi sostenere L’Appeso?


Lascia un commento