di Serena Barsottelli
Quando non ero nato, il mondo era abbandonato; quando sarò morto, il mondo sarà abbandonato; e quando sono vivo, il mondo è abbandonato.
J.M.G. Le Clézio, Estasi e materia
Non sono abituata all’alba, al suo gentile tinteggiare il crinale del monte di oro e di rosa. Dalla finestra della mia stanza, della stanza della mia casa, si vede il cemento arancio di un altro palazzo. Un pezzo di muro sbriciolato; una scritta rossa che si interrompe a metà, dove i miei occhi non arrivano. La visuale è divisa in quattro parti equivalenti: il perimetro è disegnato con un ferro curvo in cui la ruggine sta mangiando il bianco della tinta.
Qui, invece, in questa camera, guardare fuori fa aprire i polmoni; verrebbe voglia di alzarsi, avvicinarsi e aprire, fare entrare un po’ di aria. Un cartello in stampatello invita l’ospite a non provare: è tutto sigillato. Per l’aria condizionata, hanno scritto.
Davanti a questa alba così energica, mi appoggio al tavolo di legno che corre da parete a parete, immaginando di respirare l’odore frizzante del sole appena sorto. Non sento niente.
Alle mie spalle, lontano, un vagito.
L’infermiera entra senza augurarmi buongiorno. Si avvicina al letto 27/B e si china sulla paziente ancora addormentata. La sveglia con delicatezza, poi le infila il cono del termometro nell’orecchio.
«Tutto bene» le dice, mentre l’involucro appena usato scivola tra quelli sporchi. «Speriamo che oggi sia il giorno giusto!»
Annuisce, 27/B. La sua pelle è candida come il sole a mezzogiorno, quando è velato dalle nuvole e riflesso nello specchietto che penzola dalla borsa. Ti abbaglia, ma solo per un momento, poi si spegne subito. Lo fa anche la donna, accarezzandosi il pancione che il lenzuolo non riesce più a coprire.
«Il tuo turno».
Mi mette l’arnese così in profondità, che, penso, mi forerà il timpano. Non ho il tempo di dire niente, mentre lei si allontana da me e dalla camera.
«Come stai?» mi chiede 27/B.
«Bene. Tu?»
Annuisce.
Che risposta è? Ma che problema hanno tutti qui?
E poi che razza di posto: il panorama sarà stupendo, ma non c’è modo di avere un caffè decente. Al massimo un orzo. No, grazie, preferisco arrangiarmi a modo mio.
Estraggo dalla borsa un panino. Nel corso della notte è diventato più secco, la crosta si sfalda a ogni movimento delle dita. Ci vorrebbe un coltello. L’ho chiesto, non me l’hanno dato. Ci ho provato ieri pomeriggio e poi la sera, dopo il cambio turno. La risposta sempre uguale: «Contro le regole. Non potete avere un coltello in camera, qui». Neanche fosse una prigione o un cazzo di ospedale psichiatrico. Che potremmo mai fare con una lama? Dividere in due una pagnotta? Spalmare una noce di burro sulla mollica? Alzano tutti le spalle quando provo a domandarlo, ma forse con 27/B sono diversi. Forse con lei sono più buoni. Lei non è come me, lei è qui per il motivo giusto.
«Ne vuoi?» le offro mostrandole il tozzo di pane.
Scuote la testa.
«Senti, non è che avresti un coltello?»
Mi guarda come se le avessi chiesto una pistola e si volta verso il muro. Fa niente, userò le mani.
È più dura di quanto pensassi, ma alla fine la pagnotta è aperta e i suoi bordi sono frastagliati come le scogliere degli innamorati.
Portano la colazione a 27/B, le dicono che è qualcosa di leggero. Deve essere pronta per il suo grande giorno. Le sorridono, lei sorride. A me non lasciano niente.
«Posso avere un coltello?» grido dietro agli inservienti che fingono di non udirmi. «Suppongo di no, di non potere» mormoro a me stessa.
Lascio il pane sul legno, senza preoccuparmi di mettere della carta come barriera. Nella borsa c’è ancora la vaschetta di plastica chiusa. Dentro, novanta grammi di prosciutto crudo. Non dovrei mica mangiarlo, io. Non ho avuto la toxoplasmosi. Sollevo la linguetta, poi strappo via l’intera protezione. L’odore salato si diffonde nella stanza e arriva fino a 27/B. La guardo, mi guarda.
«Ne vuoi un po’?»
«Non posso».
«Ormai sei in fondo, che male ti farà?»
«No, non posso».
Scivola giù dal letto, calza quelle ridicole pantofole con il pelo azzurro e si avvia verso il corridoio. Qualcuno la ferma poco oltre la soglia, la incoraggia: «Fai bene a fare un po’ di movimento. Vedrai che così la situazione si sbloccherà prima!» Ridono, si salutano. Mi sembra di sentire il rumore del tessuto delle dita che sfiora quello della camicia da notte. Dal corridoio non arriva più niente, se non qualche cigolio di ruote, il borbottio confuso di un medico, una suoneria che continua a suonare e a suonare, mentre dall’altra parte nessuno risponde. Sarà arrivato quel momento, penso. Inutile portare il telefono in sala parto: là non prende. Là, dicono, non c’è più contatto con il mondo vero. È tutta una bolla, forse per questo è importante non avere un coltello. Potrebbe scoppiare tutto. La bolla. La pancia.
Che poi, mica penseranno che mi possa squartare la pancia da sola? Disegnare una faccia che ride da parte a parte, appena sotto l’ombelico. Ho paura del sangue, e persino di morire. Forse è anche per questo che sono qui, al 27/A, e non al 27/B. Forse è perché ho paura di morire.
Allungo le mani sulla vaschetta e lascio penzolare una fetta davanti al mio naso. Ne studio il colore, la proporzione di grasso. Dicono che più ce ne sia, più sia pregiato. A me è sempre piaciuto piuttosto magro, dal gusto deciso, ben stagionato. Da quanti mesi non ne assaggio un morso? Più o meno da quando ho scoperto di aspettare l’inaspettato. Io madre? No, grazie. Un cambiamento a cui non sono pronta. Non mi ci vedo proprio a farmi le paranoie su come si tiene in mano un fagotto; ricordarsi di tenergli su la testa, ché già è difficile mantenere in alto la propria. È che mi piace scivolare, nelle poltrone, nei pensieri, nei ricordi. Così finisco per perdermi. Perdo un frammento oggi, uno domani. Ci sono momenti in cui non penso neanche al fatto che se ne stanno andando, uno dopo l’altro. Non sono io ad aver paura di morire. Sono loro, le altre donne. Quelle che vanno avanti. Si illudono, sì, di ingannare la morte. Perpetuano il loro frammento di patrimonio genetico e si mettono l’anima in pace. I cimiteri sono pieni anche di figli, non lo sanno? Non basta metterne al mondo uno per sentirsi eterne, invincibili.
E se ci provassi? Sì, a mettermi nei loro panni. A fare la loro scelta. Al colloquio mi hanno detto che sto scegliendo la strada più facile per me, che in fondo non si è mai pronti. Vaffanculo, ho pensato. Vaffanculo, tu sei un uomo e vuoi parlarne a me, a una donna? Vaffanculo.
Non avevo considerato che gli sguardi peggiori arrivassero dalle altre. Che facciano in fretta a liberarmi la pancia, non ne posso più di questa situazione. Devo aspettare le 12:00, mi hanno detto ieri. Poi non hanno aggiunto altro. Il resto me lo sono costruita da sola, con le mie mani, come questa colazione assemblata alla buona: del pane spezzato, un lembo di carne. Il mio corpo che si apre, un altro che esce.
27/B torna in stanza quando è già buio. «Lo vuoi vedere?» mi chiede. Io annuisco, anche se non me ne frega un bel niente. Vallo a dire tu a una madre che non ti interessa del suo figlioletto. No, mica sono pazza, devo restare qui ancora qualche ora, in camera con lei e con quello. Sarà bene iniziare a farmi furba, se voglio uscirne viva. Non dico intera, sarebbe impossibile. Al massimo ricucita.
«Ha i tuoi occhi» le dico. Lo penso davvero. Gli stessi occhi velati, stanchi, quasi spenti.
Lei sorride, lo tira su e lascia che i piedini galleggino nell’aria coperti dalla tutina.
«È pesante?» chiedo. Che domanda stupida. Certo che lo è: mica è finto. «Ti ha fatto male?» continuo osservando il suo sorriso inebetito. Alza le spalle, stringe il corpicino al petto. «Tu come stai?» mi chiede. Per la seconda volta, oggi.
«Tutto risolto» le rispondo. «Tutto».
Non ne voglio parlare, perché non saprei che cosa dire. Allora concludo con un be’, congratulazioni, sono felice per te. Sto diventando brava a mentire. Se non mi conoscessi, penserei di essere stata sincera. Torno al mio letto, mi sdraio, congiungo le mani sul grembo. È così pesante il vuoto, adesso. È come un grande masso che mi schiaccia proprio lì, dove fino a poche ore fa c’era un accenno di pancia.
Dice: «Posso spegnere la luce?»
«Fai pure».
«È che sono esausta. Vorrei riposare. Mi sa che anche per il piccolo è meglio».
«Buonanotte».
«Buonanotte».
«Senti, so che sembra strano da dire, ma se hai bisogno, stanotte, sono qui».
«Anche tu».
Vorrei rigirarmi e guardarla, per capire se sia sincera, ma mi accontento della sua bugia.
***
Ho la schiena sul lettino di pelle nera. Tra noi un foglio di carta sottile che si continua a spostare guidato dalla danza del corpo. Non c’è nessuno ad asciugarmi la fronte. Continuano a gridarmi che devo spingere.
Fa male, cazzo!
Certo che fa male, ma devi farlo.
Datemi qualcosa per il dolore!
Non c’è più tempo. È una delle cose su cui avresti dovuto riflettere prima.
Davvero?
Ora spingi, forza.
Mi tengono la pancia con le mani, mi rubano il tempo e poi me lo ridanno. Non riesco a seguire le contrazioni, mi sento solo lacerare. Le pareti assorbono il rumore del mio grido e poi aspetto il momento del pianto. Non piangerà il mio bambino.
Non piange?
Signora, l’ha voluto lei.
Non piangerà il mio bambino perché così ho scelto io.
Aspettate, dove lo portate?
È importante?
Vorrei vederlo.
È sicura?
Sì. Solo un attimo. Avvicinatemelo.
L’ostetrica stringe tra le mani un involucro di panno e di carne. Me lo infila sotto il naso e mi fa respirare gli umori del sangue, della nostra simbiosi rotta. Non l’avevo mai sentito muovere. Forse non ci avevo voluto far caso.
Lo vuole stringere una volta?
Una volta è l’ultima volta.
Sì.
Lo prenda.
Me lo appoggia al petto. Dovrei sentire due cuori battere, invece non ne sento nessuno. Ci sono solo le loro parole.
Era perfetto.
Un maschietto?
Un maschietto perfetto.
Chi ucciderebbe un bambino? Io l’ho ucciso. Io ho ucciso mio figlio.
Scosto con una mano l’involucro, cerco il suo viso.
Allora vedo: un coscio di prosciutto, lì, tra le mie braccia, sul mio seno. Una dottoressa si avvicina e mi dice che devo mangiare qualcosa. Mi porge un panino con dentro il mio bambino. Sbuca il suo piede, e la sua caviglia nuda.
Le donne ridono.
Questo non è il mio bambino.
No, signora. Questo non è mai stato il suo bambino, perché lei non l’ha meritato.
***
Forse grido, forse no. Mi ritrovo sveglia, con i punti là sotto che tirano. Nella camera sono accese solo le luci di servizio. La porta che collega la camera al corridoio non è chiusa. Disegna un’ombra lunga sulla parete delle televisioni spente.
Un respiro profondo. Un vagito.
Mi giro verso la finestra, cercando di scorgere guide nel buio della notte. La pancia borbotta e ho un pensiero, un pensiero che mi costringe ad alzarmi come colta da una scossa di corrente elettrica: si è mosso? Si è mosso il bimbo?
Che stupida, no, io non ho più il bimbo. L’ho lasciato là, in sala parto; poi l’avranno seppellito e gettato come un rifiuto. Avrebbero dovuto buttare anche me là dentro. Me, insieme a lui. Me, al posto di lui.
Il vagito si fa più vivace, fino a diventare pianto.
Mi copro le orecchie, ma il rumore arriva lo stesso, anche nascondendo la testa sotto il cuscino. Qualcuno dovrebbe fermarlo, quel lamento. Non sono io a singhiozzare. Non sono io.
È un bambino. Non il mio bambino, ma un bambino sta piangendo.
A piedi nudi, senza far rumore, mi avvicino alla culla accanto a 27/B. La mamma continua a dormire nel proprio letto.
Non piangere, gli sussurro senza toccarlo.
I neonati sono così egoisti: non ascoltano, vogliono solo essere ascoltati. Non ti amano, vogliono solo essere amati.
Qualcuno dovrebbe farlo smettere o sveglierà il reparto, mentre sua madre continuerà a dormire, sfinita.
Allungo la mano, le dita vibrano nell’aria; la ritraggo: non è mio, non posso toccarlo. Forse mi sente, forse sente il mio odore: muove il suo viso verso di me, apre appena la bocca. Come sono perfette le labbra di un neonato; sono rosse, disegnano un cuore. Sono disegnati per essere amati, per essere protetti.
Io il mio non l’ho amato, non l’ho protetto. O forse sì.
Mi guardo intorno: non arriverà nessuno. Nessuna ostetrica a calmarlo, non 27/B che inizia a russare. Ho avuto scelta, prima, non adesso. Mi piego, il mio corpo ricurvo sul suo disteso.
Non ho mai tenuto in braccio un bambino così piccolo. Lo tiro su sotto le ascelle e lascio scivolare il braccio dietro la sua nuca. La testa continua a muoversi finché non troviamo un nuovo equilibrio, insieme.
Sh, sh, sh. Non sei solo, gli dico.
Fa una pausa dal pianto.
Ci sono io qui. Per stanotte puoi restare con me.
Mi avvicino a una poltrona blu, mi lascio cadere. Lui si sistema, poi si riaddormenta. Non piange più, a volte mi sembra abbozzi un sorriso.
E io lo osservo, per essere sicura che respiri. Che stia bene e non si senta abbandonato, o peggio ancora, sbagliato. Non so neanche come si chiami perché senza occhiali non riesco a leggere il nome sul foglio appeso alla culla.
I punti della ferita tirano un poco, finché non trovo la posizione giusta.
Ci addormentiamo, io e quel bambino sconosciuto, finché una mano sulla spalla mi risveglia. È 27/B e l’alba sta tingendo di rosa e di oro il crinale dei monti. Indossa una camicia da notte azzurra come il pelo delle sue pantofole.
«Grazie» mi sussurra. Prende il bambino dalle mie mani, lo stringe a sé. Questo è il secondo figlio che perdo nell’arco di un giorno. È un pensiero… be’, è un pensiero.
Mi avvicino alla grande finestra, le luci hanno una consistenza più acquosa.
«Buongiorno!» gridano alle mie spalle. Io non mi volto, non voglio che mi vedano piangere.
«Se ti sentirai bene, oggi potrai tornare a casa».
Lontano da quella culla piena, con la mia pancia vuota.
«Ti senti bene?»
«Sto benissimo».
Come dire la verità? Mi direbbe che, alla fin fine, ho scelto io.
Chiudo la borsa, manca solo il pranzo. Il neonato sta riposando. 27/B si avvicina e guarda nel mio vassoio: pasta all’olio, purè, orata lessa. Sorride scartando quello che le ha lasciato il marito: una piccola vaschetta di plastica; all’interno del prosciutto fresco, non particolarmente stagionato.
«Ne vuoi un po’?» mi chiede.
Corro in bagno, mi libero anche dei succhi gastrici. Rientro appena il tempo di afferrare i manici della borsa, gettare uno sguardo al neonato e augurargli un silenzioso buona vita.
Non si vedono i monti, da questa uscita, solo il guardrail della strada ad alto scorrimento. Non ci sono colori tenui ad attendermi, ma una distesa di grigio.
«Le chiamo un taxi?»
«No, riesco a camminare, da sola».
«Posso fare qualcosa?»
Tutta questa gentilezza, d’un tratto. Perché anche se rinunci a un figlio, per loro forse resti comunque una madre.
«Ha mangiato qualcosa? Non dovrebbe andarsene a stomaco vuoto».
Il cigolio del carrello con i vassoi degli avanzi e dei passi non consumati si avvicina dal retro, da sinistra. Il profumo dell’inserviente al mio fianco si mescola con gli odori del cibo.
Ho solo un attimo. Appena in tempo.
Mi volto, afferro la prima cosa che trovo. Un panino intero.
La porta si apre davanti a me.
Fa freddo qui. Quando è arrivato l’inverno?
Affondo i denti oltre la crosta, mi taglio appena la gengiva. Nella bocca il sapore di mollica e di sangue. Nessuna salsa, niente verdure. Neppure un brandello di carne. Dentro è vuoto.
Mi tocco la pancia, controllo: dentro è vuota.

Serena Barsottelli nasce a Viareggio nel 1985. Dopo gli studi classici, si laurea in filosofia. I suoi racconti sono apparsi sul magazine dell’Istituto Luce «Otto e mezzo» (n. 57), «Offline» (n. 18), «Gelo».
Manuela Stacca si è laureata in Scienze delle Lettere e della Comunicazione all’Università di Sassari. Dopo essersi occupata di giornalismo e critica televisiva, nel 2021 si avvicina al mondo dell’animazione 2D e ritorna alla sua prima passione: il disegno. Sue illustrazioni sono apparse su «Megazinne», «CrunchEd» e «Risme». Lo scorso aprile ha preso parte alla mostra collettiva Premio Sergio Fedriani 2023. Attualmente, sta lavorando al suo primo corto animato.

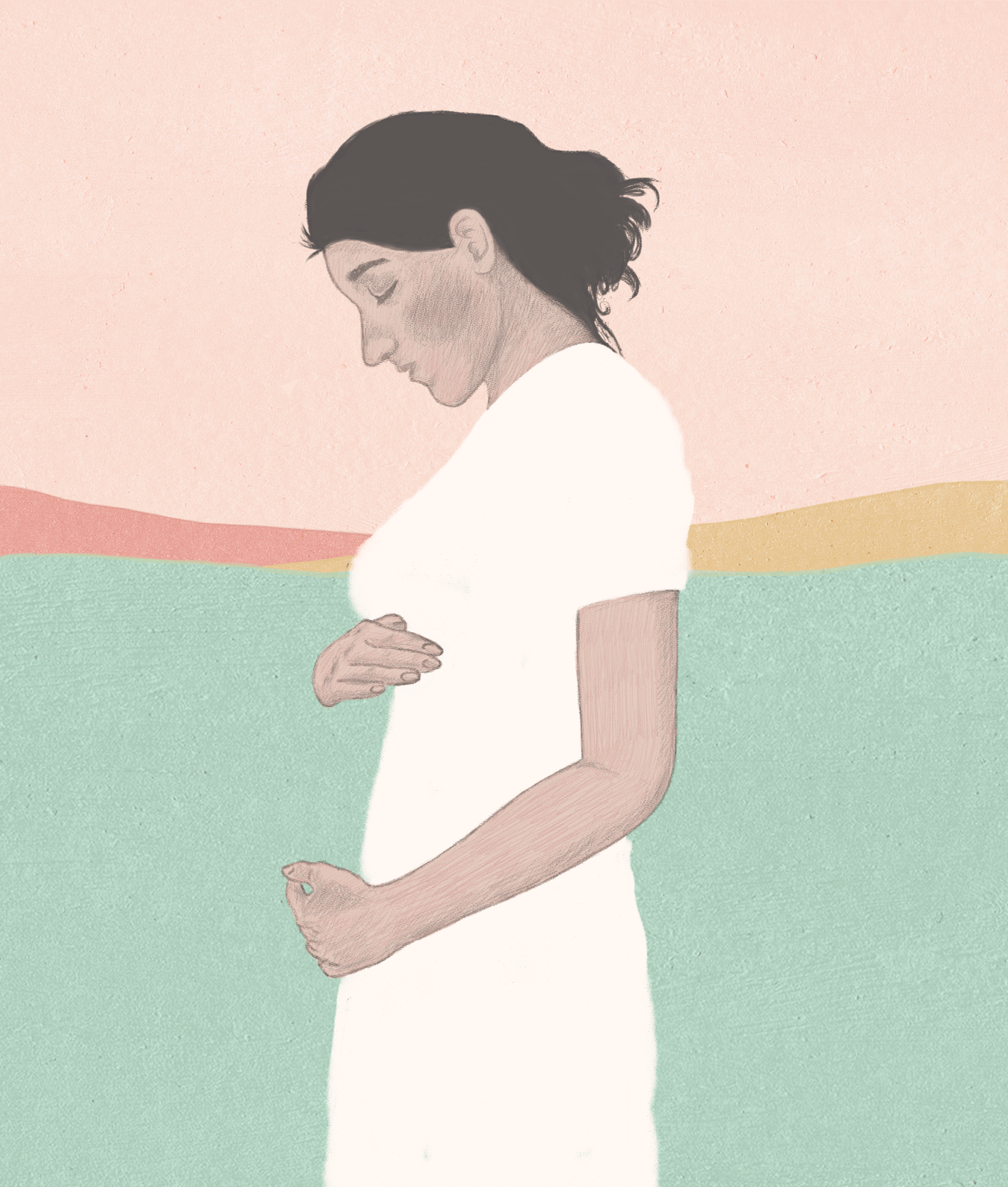
Lascia un commento